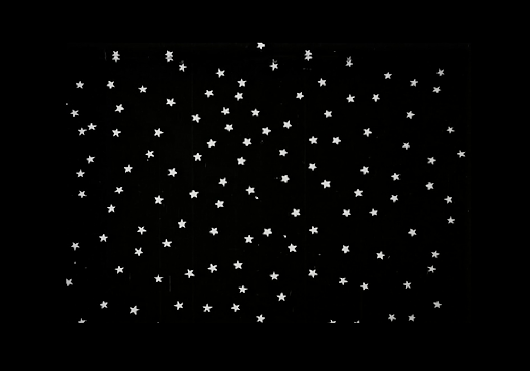UZAK 32 | autunno 2018 - inverno 2019
Editoriale
L'editoriale di fine anno è facile da scrivere: a meno che non sia accaduto qualcosa di eclatante in ambito teorico - il che richiederebbe un'attenzione speciale, tutta una messa a fuoco sul visibile contemporaneo che però sarebbe evanescente se paragonato alla bieca flagranza della pubblicistica, dell'icasticità salviniane: ma soffermarmi su questo fenomeno sarebbe sadico da parte di un'indole malinconica, e soprattutto ripetitivo visto che lo ha fatto, latamente, Franco Berardi, "Bifo", con un libro molto bello, Futurabilità edito da «Nero», come già Realismo capitalista di Fisher- si tratta di riassumere l'anno appena trascorso, attraverso immagini, pagine, suoni resistenti.
Tags:
"Magic lantern": affettuoso adieu à (une certaine) langage
«L'importante per me era sfidarmi ancora, superare quello che avevo già fatto, e dopo aver fatto crollare le montagne in Monte (Amir Naderi, 2016), per andare avanti in quella direzione avrei dovuto aprire gli oceani come Mosè. Quindi ho capito che era il momento per un cambio di direzione radicale rispetto a quello che ho fatto sinora, una sfida che investisse anche il piano stilistico, qualcosa che non avevo mai fatto prima».
Tags:
I predatori del tempo. "Possessed"
Tra le rovine del comunismo, uno spettro si aggira nei deserti di una generazione, e lì, tra edifici collassati, Olivia Lonsdale incarna ciò per Alex Williams è questo (nostro) sentire (il sentire di una intera generazione)
Cosa è questo essere nati troppo tardi? Questo sentire di essere nati troppo tardi? La sensazione di essere venuti dopo qualcosa… Ma questo guardare al passato come a un età dell’oro dai grandi momenti, delle grandi storiche conquiste – e nel film la parola ‘passato’ tuonerà e salirà come un mantra, ripetendosi come in un rituale magico– non tradurrà l’oblio in nostalgia, non guarderà esotico a un ritorno dello stesso; annullerà, bensì, l’idea stessa di futuro che in quegli anni amorevolmente vi si cucì per i nuovi arrivati. L’impossibilità di rapportarsi con questa linea del tempo, l’impossibilità di procedere verso un proprio generazionale futuro non lascia spazio se non al ripensare a quella passata idea di futuro. O accelerare, verso una densa automazione del presente.
Tags:
Blu: «E quindi uscimmo a riveder le stelle». La peregrinazione sotterranea di D'Anolfi e Parenti
Passa nella sezione Orizzonti della settantacinquesima kermesse veneziana l'ammaliante Blu, nuova stanza della ballata audiovisuale degli invisibili, scritta e cantata da quello chansonniere bicefalo che risponde ai nomi di D'Anolfi e Parenti.
Tags:
★ di Johann Lurf
«Nei neri spazi interplanetari quegli sciami si sparpagliavano variamente, seminando polvere di meteore di abisso in abisso. Sperduti negli spazi infiniti, avevamo quasi smarrito il globo terrestre sotto i piedi e disorientati, senza più direzione, pendevamo come antipodi, a testa in giù , sopra uno zenith rovesciato, e ci aggiravamo fra quegli ammassi stellari, passando il dito bagnato di saliva lungo interi anni-luce di stella in stella. Così vagavamo nel cielo in lungo ordine sparso, disperdendoci in tutte le direzioni per gli scalini infiniti della notte: emigranti di un globo abbandonato, che saccheggiavano le sconfinate masse formicolanti di stelle.» (B.Schulz, Le botteghe color cannella).
Di stella in stella, di cielo in cielo, in ★ di Johann Lurf assistiamo ad un gioco di tempi in cui ogni frammento notturno viene strappato alla temporalità del proprio film per incastrarsi e concatenarsi come in un mosaico in un via vai di cieli stellati.
Tags:
"Ni De Lian (Your Face)": Tsai-Ming Liang tra analisi filmica ed "embodiment"
Da Alcuni anni oramai si invoca, tanto da parte degli studi di ambito cognitivo che di quelli filmologici, la necessità di una convergenza interdisciplinare, e di una sintesi funzionale tra i reciproci paradigmi d’analisi. Il presente contributo intende muoversi in questa direzione tentando la via di una struttura funzionale integrata tra i due livelli di descrizione diversi, quello critico filmologico e quello relativo ai processi di embodiment.
Tags:
Rissa al centro del cinema di Zahler
* Una prima versione di questo articolo è uscita sul «Manifesto» del 22-11-2018.
Brawl In Cell Block 99, secondo film di Craig Zahler, rappresenta un caso davvero clamoroso di quelle lacune endemiche della distribuzione italiana, che spesso, oltre a trascurare il valore intrinseco di alcuni film, pare tralasci anche quello più esteriore, di confezione (di cui dovrebbe essere esperta), mancando di soppesarne elementi di potenziale e diffusa commercializzazione. In effetti in quanto a vendibilità Zahler non è meno attraente di Tarantino, anche al di là dell'immediato sfolgorio e del crepitare tutto plasticoso1Il termine “plasticoso” sarebbe un neologismo e lo prendo dal lessico e proprio dalla filosofia di Luca Abiusi (animatore prima di retrogamer.it ora di projectfirestart.org), che determinano un ambito dialettico, ermeneutico molto connotato, quello del videogame degli albori, con la propria meccanica a bip e fosfori verdi e le linee meravigliosamente minimali e stereotipate: creature, laconici avventurieri e navicelle spaziali a pixel, mostri e combattenti a mani nude in un mondo di pochi bit, divenuti in breve tempo fonte di feticismo e di studio, soprattutto al tempo delle ultradefinite consolle contemporanee. È un intimo corrispondersi tra questa meccanica e i tratti archeologici delle sagome sul monitor, con l'involucro di plastica posto fuori, la consolle dotata delle sue escrescenze di joystick, floppy, scricchiolanti registratori a nastri. Ma, anora, “plasticoso” non è “plastificato”; non indica l'essere fatto di plastica di un determinato oggetto, ma, mettendo in relazione oggetto e soggetto fruitore (dopo che si è capito il legame tra la plastica che compare sullo schermo e quella che sta fuori, in termini di supporto), dice il feticismo, il piacere per l'artificiosa flagranza, per il crepitare della cosa di plastica. della superficie, dell'involucro così feticisticamente fantoccesco dei loro film (o di alcuni loro film).
Tags:
La violenza, la calma
Nei film diretti da Craig Zahler, scrittore, musicista e regista, prima o poi succedono cose terribili (scene di cannibalismo, teste spiaccicate, pestaggi, torture…) ma accadono con tutta calma, senza fretta – se di una certa “fretta” si può parlare, questa è riservata semmai alle scene culminanti, quelle che un tipico regista hollywoodiano cercherebbe in tutti i modi di valorizzare. Zahler, invece, si diverte a “rallentare”, inserendo particolari che non hanno diretta attinenza con la storia raccontata, o sembrano inessenziali, oppure mettendo in bocca a personaggi di modesta o rustica estrazione considerazioni complesse sulla vita e sulla morte (spesso auto-ironiche) degne d’un filosofo, o d’uno scrittore (quale Zahler è).
Tags:
Black Metal. Su S. Craig Zahler
Ricordate l’incipit dello Squalo II (J. Szwarc, 1978)?1Non si nasconde forse nelle pieghe della logica completamente consumista del sequel, meglio quando del tutto apocrifo (e anche “mancato”, addirittura mal riuscito), la possibilitá sempre virtuale di un reframing, di re-inquadrare la realtà che si credeva fissa e stabile dell’episodio I in modo trasversale e inaspettato per far sorgere così nuovi significanti? Nel fondo dell’oceano, una fotocamera subacquea cade dal braccio mozzato del sommozzatore; l’urto con il fondale sabbioso (dopo una serie di rimbalzi che possiedono la sospensione incredula dell’oggetto a gravità zero cameroniano- kubrickiano e la malinconia invincibile del primo passo sulla luna) fa scattare, accidentalmente, una foto. Ma l’obbiettivo, dov’era puntato? Verso chi o verso Cosa lancia o genera il suo fascio automatico di luce biancastra? Verso lo sterminato fuori campo che si prolunga più in là del margine destro del quadro?
Tags:
"Dragged Across Concrete". Mappa del tempo
* Articolo già apparso su filmparlato.com.
A di là della prospettiva ludica che ormai accompagna ogni film di Zahler al suo annuncio - tutto quell'apparato plastico, splatter, come una fermentazione della materia cinematografica secreta, spruzzata, esplosa fuori dalla sua forma (come dimenticare il trascinarsi e consumarsi delle teste di pupazzo sul pavimento in Brawl In Cell Block 99 o lo svuotarsi del corpo, lo spreco così posticcio delle viscere gommose del vicesceriffo in Bone Tomehawk?), e l'avventura dentro gli spazi del genere, il consumo immediato che se ne possa fare - il cinema di questo onnivoro modulatore di trame (comprendendo anche i romanzi, le sceneggiature per altri registi e le musiche per i suoi film), a uno sguardo più attento, mostra una tensione spiccata verso delle resistenti strutture di immaginazione, delle forme di rappresentazione durature che si organizzano intorno al concetto, alla percezione di tempo e fungono da contrappeso (oltre che da contenitore) a quella pratica di consumo tutto intestino, in nome di un equilibrio del film che, ora che è passato anche Dragged Across Concrete a Venezia, si può considerare propriamente zahleriano.
Tags:
Le livre d'image
Si apre l’immagine come un foglio da decifrare, tanti fogli rilegati uno ad uno a contenere mondi e al di là, chiusi eppure pronti ad essere sfogliati. Le livre d’image è, appunto, un libro che si racconta e ci lega, è image et parole che prendono forma ogni volta che le livre entra in possesso del nostro sguardo e la palpebra si apre. Il tocco di Godard che ricompone ancora una volta la sua Histoire(s) du cinema, abisso su cui rimettere continuamente le mani per andare più a fondo (ché l’immagine in fondo è un precipizio di cui non si vede mai la fine), mette in chiaro la sua idea di (non) fare cinema come se quell’infinito del verbo implicasse un lavoro instancabile che gira intorno ad un’unica interrogazione: cos’è il cinema?
Tags:
Ce n'est pas une image juste, c'est juste une image
«Tutto comincia in immagini...bei desideri, dolci e violenti come le falci, nell'erba tenera che arrossa...»
(Paul Éluard)
«La prima immagine di Nana di schiena è la prima idea che ho avuto. Non sapevo assolutamente che cosa avrei fatto in questo film: avevo due pagine di sceneggiatura che descrivevano grosso modo il film così com’è. Avevo un’unica idea molto precisa…era che la prima inquadratura sarebbe stata lei vista di schiena. Per quale motivo, sarei del tutto incapace di spiegarvelo».
Tags:
Avvicinamento e liberazione dell’immagine
Nell’indefesso proliferare di elucubrazioni, ripensamenti e rimemorazioni per immagini, parole e suoni che è la lunghissima carriera di Jean-Luc Godard, il regista francese non ha mai smesso di chiedersi in che modo il linguaggio cinematografico possa essere di volta in volta lavorato per continuare ad essere valido strumento di filatura del pensiero, del pensum, la lana grezza del cogitare umano. Lui, che una volta definì i film «arazzi in cui poter ricamare le proprie idee» e che si è sempre reputato – sin da una nota intervista, rilasciata ai Cahiers du Cinema nei primi anni Sessanta – un «saggista», uno che realizza «saggi in forma di romanzo» o «romanzi in forma di saggio», ma al posto di scriverli, li filma.
Chiuso nella villa-laboratorio di Rolle, nella quale da decenni s’è rintanato per poter esercitare in piena libertà e quiete la sua attività di sperimentazione intellettuale e artistica, Godard, le cui opere non sono certo mai state concepite per un consumo rilassato e acritico, ha portato avanti la sua impresa di “distruttore” (tale era la forza disgregante, ben oltre l’iconoclastia, che gli riconosceva Susan Sontag) e al contempo ricostruttore di cinema. Liberando l’immagine dal flusso ipnotico e illusorio del découpage classico e del suo montaggio invisibile, rifuggendo dalla melodia monodica della narrazione intesa come rappresentazione, per recuperare la discontinuità e l’incoerenza del reale (ma anche dell’immaginario) e affidarsi alla polifonia della composizione contrappuntistica. I cui punti (contro punti) sono materiali eterogenei (suoni, rumori, immagini, testi) stralciati dai contesti originari, accumulati, manipolati e messi tra loro in relazione e frizione, assonanza e dissonanza, nella piena trasparenza del processo poietico, di scrittura.
Acme di questo processo di traslazione e riconfigurazione sono sicuramente le Historie(s) du Cinéma e di qui bisogna partire per parlare di Le livre d’image, ultima rapsodia godardiana passata quest’anno in concorso a Cannes, dove le è stata assegnata una “palma d’oro speciale”. Come negli otto capitoli delle storie di cinema cominciate nel 1988 e terminate dieci anni più tardi, anche in questo “libro d’immagini” coesistono frammenti letterari e poetici, frame ed estratti della grande storia del cinema, voci narranti, quadri, suoni ed elementi grafici racchiusi in cinque capitoli (Remakes, Les Soirées de Saint-Pétersbourg, Ces fleurs entre les rails, dans le vent confus des voyages, L'esprit des lois, La région centrale). Cinque, come le dita della mano (che infatti appare subito, immediatamente dopo il bip tecnico del segnale di sincronismo da 1000hz che apre il film), dettaglio virato verso il bianco del San Giovanni Battista di Leonardo da Vinci. Ma anche – come suggerisce lo stesso Godard in voice-over – cinque come «i cinque sensi, le cinque parti del mondo, le cinque dita della fede». Cinque falangi che compongono l’organo prensile, strumento del fare per antonomasia. Perché «la vera condizione dell’uomo è pensare con le mani» (una frase, appartenente a Denis de Rougemont, già utilizzata proprio nelle Historie(s) e dunque riciclata, rimessa in uso), passare dal pensiero all’azione, far filare la lana grezza del pensum, come dicevamo all’inizio, aiutati da quell’immenso opificio che è l’arte.

L’arte, appunto. Nel terzo capitolo, Ces fleurs entre les rails, dans le vent confus des voyages, rinominato con la musicalità e l’elegiaca figuratività di un verso d’ineffabile bellezza di Rilke, la voce fuori campo di Godard ne offre all’uditore una definizione che potremmo definire di matrice materialista, parafrasando una riflessione di Hollis Frampton, anch’essa presente in Histoire(s): «nel momento in cui due secoli si dissolvono l’uno nell’altro, alcuni individui trasformano i mezzi di sussistenza in nuovi mezzi. Questi ultimi sono ciò che noi chiamiamo arte».
Hollis Frampton, grande teorico dell’arte visiva, regista d’avanguardia e pioniere del video digitale, così simile a Godard, nel suo incandescente sperimentare, nel mettere le mani (di nuovo loro) nella struttura dell’opera filmica, nel magma dove avviene la fusione e modellazione degli elementi che poi diventano il film stesso (Frampton fu infatti uno dei massimi esponenti dello structural film, movimento di cui fece parte anche Michael Snow, il celebre avanguardista autore di La Région Centrale, di cui alcuni frammenti appaiono nell’ultimo omonimo capitolo di Le Livre d’image).
Non è un caso che un suo saggio, “For a Metahistory of Film: Commonplace Notes and Hypotheses”, giocò un ruolo chiave nel contestualizzare Histoire(s) du cinéma, circolando tra giornalisti e critici quando l’opera video ad episodi fu lanciata a Cannes nel 19971Per approfondire si veda Michael Witt, Jean-Luc Godard, Cinema Historian, Indiana University Press, 2013. Vi si teorizzava un’idea di cinema come di un grande apparato fatto d’ogni singolo fotogramma, immagine in movimento e suono mai registrati, a formare un mastodontico «film infinito», sempre in espansione. Non solo – e qui ci viene in soccorso Micheael Witt – «ogni documentario e film di finzione realizzato, ma anche le innumerevoli ore degli home movies e dei filmati scientifici, educativi, promozionali e industriali che languono negli archivi e negli attici di tutto il mondo2Ib., p.109». Dato che per uno storico del cinema sarebbe del tutto impossibile fornire una storiografia accurata di cotanta mostruosità, Frampton coniò la figura del metastorico, qualcuno che avrebbe dovuto «inventare una tradizione, cioè un set maneggevole e coerente di monumenti indipendenti, incaricati di inseminare di una nuova significativa coerenza il corpo crescente della sua arte3Ib., p.110». Se opere del genere non fossero risultate reperibili, il metastorico avrebbe dovuto avere il dovere di realizzarle o, nel caso in cui fossero invece disponibili, di rifarle. Re-make, appunto.
Torniamo così a Le Livre d’Image e al suo primo capitolo. Non è possibile capire il senso di quest’ultima opera di Godard e delle sue histoire(s) di cinema se prima non si riflette accuratamente sul concetto di rapprochement che accomuna Godard e Frampton (ma anche Bresson, che spesso indicava questa forza magnetica come cardine del suo cinema, e altri cineasti ancora): l’avvicinamento di due oggetti, artefatti, persone o eventi non direttamente collegati tra loro.
Per JLG è, tout court, il cinema stesso ad essere «avvicinamento di cose che dovrebbero essere riportate assieme, ma che non sono predisposte ad esserlo4M.Temple, J. Williams (a cura di), The Cinema Alone: Essays on the Work of Jean-Luc Godard, 1985-2000, Amsterdam University Press, 2000, p.29». E se, come recita la nota formulazione di Pierre Reverdy, «l’immagine è una creazione pura dello spirito», allora «essa non può nascere da una comparazione, ma da un avvicinamento di due realtà più o meno lontane.

Più i rapporti tra le due realtà avvicinate saranno lontani e giusti, più l’immagine sarà forte – più essa avrà potenza emotiva e realismo poetico5Reverdy in G. Angeli, Tradizione e contestazione IV. Le avanguardie. Canone e anticanone. Ediz. Italiana e francese, Alinea, 2009, p.143.». È da questa combinazione per analogie che nascono opere simili a costellazioni, come Historie(s) du Cinéma e Le livre d’image. Il mezzo per ottenere il rapprochement è ovviamente il montaggio, che Godard intende non come mera giustapposizione, ma come contrappunto, alla maniera di Pelešjan, autore non a caso profondamente amato da Godard, altro grande riciclatore di immagini e suoni che diventano qualcosa di nuovo.
Del resto «il contrappunto – declama cavernosamente la voce di Godard nel suo libro illustrato – è la disciplina della sovrapposizione» e in questo turbine sincopato di entità fantasmatiche, composto dalla mente musicale di Godard con tempi plurali e ritmi composti, la Storia incontra le storie, il cinema il mondo, in un meraviglioso anacronismo che fonde immagine e tempo.
Breve storia di un fuoricampo possibile: "Le livre d’image" di Jean Luc Godard
«La Storia è isterica: essa prende forma solo se la si guarda – e per guardarla bisogna esserne esclusi».
R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia.
L’isterismo della Storia, che Roland Barthes slegava dallo sguardo, ma da uno sguardo che pure è affrancato dall’appartenenza, come se soltanto nel non-luogo del distacco ci fosse la forma vera delle cose, la loro dinamica, muove dagli occhi, dalla voragine delle pupille dilatate: a patto di restare lontani, esclusi appunto dalla trama degli accadimenti, per essere trafitti dalla visione, e inondati da pezzi di mondi, da pezzi di vite e pezzi di sguardi. Sulla stessa linea palpitante, intensamente straniante procede, tratto a tratto, infranto e ricomposto dagli ingranaggi del montaggio, Le livre d’image, che è ancora una volta – e forse, adesso, ancora di più – discorso sul Cinema, se non domanda su quale ruolo abbia il cinema nelle innumerevoli possibilità d’essere (d’esserci) nel fulgore lacerante del reale.
Tags:
Panorama. Il teatro politico di Motus
Motus, etimologicamente indica il participio passato del verbo latino movere; Motus come movimento, spinta come breccia nel buio, dislocazione continua, trasformazione. Motus, la compagnia teatrale fondata da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, si fonda su questa ricerca che è perenne spinta del corpo (scenico e attoriale) verso un altrove. Il superamento del confine sembra essere la parola chiave del lavoro di questa compagnia: l’idea di soglia perennemente messa in discussione. Panorama è il titolo della loro ultima produzione teatrale nata in stretta collaborazione con la Great Jones Repertory Company de La MaMa, teatro dell’East Village newyorkese fondato da Ellen Stewart e sembra essere il proseguo di un discorso già avviato con MDLSX attraverso il corpo androgino di Silvia Calderoni costantemente aperto e coinvolto con tutto ciò che lo attraversa.
Tags:
Rassegne
-
Registi fuori dagli ScheRmi
-
Registi fuori dagli ScheRmi II
-
Registi fuori dagli ScheRmi III
-
Registi fuori dagli scheRmi IV
-
Speciale Registi fuori dagli scheRmi IV
-
Registi fuori dagli scheRmi V
-
Speciale Registi fuori dagli scheRmi V
-
Registi fuori dagli scheRmi VI
-
Registi Fuori dagli ScheRmi VII
-
Registi fuori dagli Sche[r]mi VIII
-
Registi fuori dagli sche[r]mi IX
-
Registi fuori dagli sche[r]mi X
-
Registi fuori dagli scheRmi XI
-
immaginesomiglianza
-
Registi fuori dagli scheRmi XII
-
Registi fuori dagli scheRmi XIII
Archivio
- Uzak 50/51 | inverno/primavera 2026
- Uzak 48/49 | inverno/primavera 2025
- Uzak 46/47 | estate/autunno 2024
- Uzak 45 | inverno/primavera 2024
- Uzak 44 | estate/autunno 2023
- Uzak 43 | inverno/primavera 2023
- Uzak 42 | estate/autunno 2022
- UZAK 41 | inverno/primavera 2022
- Uzak 40 | estate / autunno 2021
- Uzak 39 | primavera 2021
- UZAK 38 | autunno 2020/ inverno 2021
- Uzak 37 | estate 2020
- Uzak 36 | primavera 2020
- Uzak 35 | autunno 2019 / inverno 2020
- Uzak 34 | estate 2019
- UZAK 33 | primavera 2019
- UZAK 32 | autunno 2018 - inverno 2019
- UZAK 30/31 | estate 2018
- UZAK 28/29 | autunno 2017 / inverno 2018
- UZAK 27 | estate 2017
- UZAK 26 | primavera 2017
- UZAK 24/25 | autunno/inverno 2016
- UZAK 23 | estate 2016
- UZAK 22 | primavera 2016
- UZAK 20/21 | autunno/inverno 2015
- UZAK 19 | estate 2015
- UZAK 18 | primavera 2015
- UZAK 16/17 | autunno/inverno 2014
- UZAK 15 | estate 2014
- UZAK 14 | primavera 2014
- UZAK 12/13 | autunno/inverno 2013
- UZAK 11 | estate 2013
- UZAK 10 | primavera 2013
- UZAK 09 | inverno 2013
- UZAK 07/08 | estate/autunno 2012
- UZAK 06 | primavera 2012
- UZAK 05 | inverno 2011
- UZAK 04 | autunno 2011
- UZAK 03 | estate 2011
- UZAK 02 | primavera 2011
- UZAK 01 | inverno 2010