UZAK 27 | estate 2017
Editoriale. Portogallo
 Mentre scrivo arrivano notizie sui vincitori del Festival di Locarno, oramai riserva di visioni scintillanti, libere, orientate verso spazi in fieri, arcipelaghi di sensi nell’oceano dei possibili significati; inferenze improvvise, insorgenze poste fuori dalle classificazioni libresche della Storia e dentro un dis-ordine geografico cinematografico, come un affiorare spontaneo di spazi-tempo, di atmosfere gonfie d'aria elettrica, un'eterogenesi diffusa di ciò che si chiama immagine, ecc., almeno da quando il direttore è Chatrian e allora accanto al monstrum Tourneur si possono vedere autori come Ossang (miglior regia), Russell, Cabeleira (menzione speciale a "Cineasti del presente"), lì dove già avevano regnato Serra, Zulawski, Costa, a cui si aggiunge ora Wang Bing (vincitore del concorso).
Mentre scrivo arrivano notizie sui vincitori del Festival di Locarno, oramai riserva di visioni scintillanti, libere, orientate verso spazi in fieri, arcipelaghi di sensi nell’oceano dei possibili significati; inferenze improvvise, insorgenze poste fuori dalle classificazioni libresche della Storia e dentro un dis-ordine geografico cinematografico, come un affiorare spontaneo di spazi-tempo, di atmosfere gonfie d'aria elettrica, un'eterogenesi diffusa di ciò che si chiama immagine, ecc., almeno da quando il direttore è Chatrian e allora accanto al monstrum Tourneur si possono vedere autori come Ossang (miglior regia), Russell, Cabeleira (menzione speciale a "Cineasti del presente"), lì dove già avevano regnato Serra, Zulawski, Costa, a cui si aggiunge ora Wang Bing (vincitore del concorso).
Pesaro 53 – Il paesaggio infinito
 «Questa tassonomia... deve intendersi come un prontuario per difendersi dalle sirene dello spettacolo contemporaneo e come un grido d’allarme per la pericolosa pedagogia della trasmissione culturale che vediamo tristemente all’opera nel nostro presente. [...] La difesa della forma – che è sempre e comunque anche contenuto – è oggi una vera battaglia culturale d’avanguardia (non d’élite!) che bisogna saper vincere contro i fautori del presentismo, i tribuni del semplicismo estetizzante e i sacerdoti dello spettacolo post-politico». F. Rossin
«Questa tassonomia... deve intendersi come un prontuario per difendersi dalle sirene dello spettacolo contemporaneo e come un grido d’allarme per la pericolosa pedagogia della trasmissione culturale che vediamo tristemente all’opera nel nostro presente. [...] La difesa della forma – che è sempre e comunque anche contenuto – è oggi una vera battaglia culturale d’avanguardia (non d’élite!) che bisogna saper vincere contro i fautori del presentismo, i tribuni del semplicismo estetizzante e i sacerdoti dello spettacolo post-politico». F. Rossin
Della tecnica, dell'etica, della forma filmica: conversazione carbonara con Nicolas Rey e Federico Rossin
 Federico Rossin, passeur militante
Federico Rossin, passeur militante
L'arrivo del cinema fotochimico di Nicolas Rey al festival di Pesaro ha avuto quantomeno, fatto raro in questa «epoca malefica in stolto secolo», il valore di riaccendere gli animi e il dibattito, riuscendo a rinfocolare quella faziosità semidormiente e sonnacchiosa di noi critici, pacificati da legami di amicizie e convenienze professionali, che invece resta ancora una delle virtù redimenti del discorso possibile sul cinema, il suo valore dialettico.
Sokurov: la stratificazione plurima, il virtuale e il postmoderno. Su Francofonia
 La radice postmoderna del cinema di Sokurov è la risultante di una serie di operazioni o passaggi che possono essere individuati (al di là del facile gioco delle coppie antitetiche concentrazione-dispersione, confine-palinstesto, selezione-combinazione, paradigma-sintagma, radice-rizoma, origine-differenza che contribuisce solo a definire una prassi teorica) nel rapporto che si instaura fra le diverse serie di sequenze-sintagmi date più che dal regime mimetico che regola e impone un sistema di rapporti di tipo relazionale, da un regime estetico (Ranciere) di eloquenza dell’iscrizione sul corpo dell’immagine e, insieme, di mutismo dell’oggetto.
La radice postmoderna del cinema di Sokurov è la risultante di una serie di operazioni o passaggi che possono essere individuati (al di là del facile gioco delle coppie antitetiche concentrazione-dispersione, confine-palinstesto, selezione-combinazione, paradigma-sintagma, radice-rizoma, origine-differenza che contribuisce solo a definire una prassi teorica) nel rapporto che si instaura fra le diverse serie di sequenze-sintagmi date più che dal regime mimetico che regola e impone un sistema di rapporti di tipo relazionale, da un regime estetico (Ranciere) di eloquenza dell’iscrizione sul corpo dell’immagine e, insieme, di mutismo dell’oggetto.
Tentativo di stanza

«A tutti, all’altro mondo,
ci toccherà saldare con il vuoto
il calcagno che pesa»
(Marina Cvetaeva)
Un vuoto dove passa ogni cosa è il titolo di una raccolta di scritti politici di Maria Teresa Di Lascia (Di Lascia 2016) che non c'entra nulla con il cinema ma che giustifica l'idea di dedicare uno speciale sul vuoto in una rivista di cinema: l'urgenza – la tentazione è di definirla “politica” nonostante il termine sia tra i più abusati, fraintesi e svuotati in senso deteriore – è nel tentativo di attraversamento (“dove passa”). Questa introduzione si compone per scelta calibrata di una serie di citazioni da libri molto diversi tra loro ma che pure ruotano intorno a quella urgenza fondamentale.
Vuoto del godimento e godimento del Vuoto
 Quando Gemma Adesso mi ha chiesto di partecipare a questo numero di “Uzak”, ricordava un mio testo in omaggio a Carmelo Bene, pubblicato nell’aprile 2003 sulla rivista «Lo Straniero» e intitolato Carmelo Bene o lo splendore del vuoto (Dumoulié 2011). Sebbene non abbia voluto scrivere ancora sul teatro o sul cinema di Carmelo Bene, il presente articolo – con il suo titolo, i suoi temi, le figure che evoca, e persino con i suoi riferimenti teorici – è abitato dallo spirito di Carmelo e riecheggia quel furore sublime e quello splendore del vuoto che era l’essenza stessa del suo teatro. In particolare, affronta due figure maggiori del suo universo poetico: la mistica, incarnazione del “godimento della donna”, e Don Giovanni. Figure che si oppongono e al tempo stesso si raggiungono, come due modi di rispondere alla stessa crisi storica: quella dell’epoca barocca, nella quale l’allontanamento di Dio ha scavato nel mondo un Vuoto di cui, paradossalmente, è possibile godere sul piano dell’intelletto, del corpo e del significante, ma anche a vantaggio di una poetica e di un’estetica del Vuoto1. (Cfr. Dumoulié 2012).
Quando Gemma Adesso mi ha chiesto di partecipare a questo numero di “Uzak”, ricordava un mio testo in omaggio a Carmelo Bene, pubblicato nell’aprile 2003 sulla rivista «Lo Straniero» e intitolato Carmelo Bene o lo splendore del vuoto (Dumoulié 2011). Sebbene non abbia voluto scrivere ancora sul teatro o sul cinema di Carmelo Bene, il presente articolo – con il suo titolo, i suoi temi, le figure che evoca, e persino con i suoi riferimenti teorici – è abitato dallo spirito di Carmelo e riecheggia quel furore sublime e quello splendore del vuoto che era l’essenza stessa del suo teatro. In particolare, affronta due figure maggiori del suo universo poetico: la mistica, incarnazione del “godimento della donna”, e Don Giovanni. Figure che si oppongono e al tempo stesso si raggiungono, come due modi di rispondere alla stessa crisi storica: quella dell’epoca barocca, nella quale l’allontanamento di Dio ha scavato nel mondo un Vuoto di cui, paradossalmente, è possibile godere sul piano dell’intelletto, del corpo e del significante, ma anche a vantaggio di una poetica e di un’estetica del Vuoto1. (Cfr. Dumoulié 2012).
Filmare il vuoto
 Riflettendo (in Tokyo-Ga) sul cinema di Yasujiro Ozu, Wim Wenders ricorda che da ragazzo si chiedeva come fosse concepibile la nozione di Nulla, e poi in che modo fosse applicabile al cinema, arte del concreto – per concludere che il Nulla è irrappresentabile, ma è rappresentabile il suo incombere, il suo incidere progressivo sulle cose e sui corpi, l'avvicinamento alla fine, al grande Vuoto. Non per nulla, aveva seguito le ultime settimane di vita di Nicholas Ray (in Lampi sull'acqua), inaugurando quella che sarebbe poi diventata una specie di moda (filmare le ultime ore di un parente, un amico, una persona cara) e violando il famoso interdetto baziniano (filmare la morte, o l'agonia, è osceno, come girare un film porno).
Riflettendo (in Tokyo-Ga) sul cinema di Yasujiro Ozu, Wim Wenders ricorda che da ragazzo si chiedeva come fosse concepibile la nozione di Nulla, e poi in che modo fosse applicabile al cinema, arte del concreto – per concludere che il Nulla è irrappresentabile, ma è rappresentabile il suo incombere, il suo incidere progressivo sulle cose e sui corpi, l'avvicinamento alla fine, al grande Vuoto. Non per nulla, aveva seguito le ultime settimane di vita di Nicholas Ray (in Lampi sull'acqua), inaugurando quella che sarebbe poi diventata una specie di moda (filmare le ultime ore di un parente, un amico, una persona cara) e violando il famoso interdetto baziniano (filmare la morte, o l'agonia, è osceno, come girare un film porno).
Quand vous faites l’amour avec moi vous pensez à la mort? (allucinazioni euristiche su La Maman et la Putain (1973) di Jean Eustache)
 «I'm beggin' please, little lover, stop this carryin' on
«I'm beggin' please, little lover, stop this carryin' on
gotta get some lovin' before the planet is gone
A nuclear bomb come an' blow us all away
Come on, bad girl, give me some lovin' today»
(New York Dolls)
«Elle était belle à la fois de la beauté fugace d’une actrice et
de la beauté souveraine de la catastrophe»
(J. Gracq)
Ethica. Natura e origine della mente. O del Vedersi vedere
 Il problema dello sguardo, e in particolare dello sguardo dell'altro è da sempre centrale nel fare della Socìetas Raffaello Sanzio, compagnia teatrale creata nel 1981 da Romeo Castellucci insieme a Claudia Castellucci, Chiara Guidi e Paolo Guidi, che, riprendendo il titolo di un loro testo, ha mosso i primi passi nel solco dell'iconoclastia per arrivare confrontarsi con la super-icona (basti pensare allo spettacolo Sul concetto di volto nel Figlio di Dio).
Il problema dello sguardo, e in particolare dello sguardo dell'altro è da sempre centrale nel fare della Socìetas Raffaello Sanzio, compagnia teatrale creata nel 1981 da Romeo Castellucci insieme a Claudia Castellucci, Chiara Guidi e Paolo Guidi, che, riprendendo il titolo di un loro testo, ha mosso i primi passi nel solco dell'iconoclastia per arrivare confrontarsi con la super-icona (basti pensare allo spettacolo Sul concetto di volto nel Figlio di Dio).
Frantz di François Ozon. Il linguaggio segreto.
 1919 Quedlinburg (Germania). La guerra è finita, e Anna (Paula Beer), una giovane donna in lutto si reca al cimitero per porre dei fiori sulla tomba (vuota) del suo fidanzato caduto sul fronte. Un giorno si accorge di uno sconosciuto che a sua volta, di nascosto, svolge lo stesso pietoso rito: si tratta di Adrien, un francese (Pierre Niney), prima accolto con risentita ostilità dal padre e poi accettato da entrambi i genitori di Frantz, presso i quali lei ormai vive, per colmare di purissimo affetto il vuoto lasciato dall’amato.
1919 Quedlinburg (Germania). La guerra è finita, e Anna (Paula Beer), una giovane donna in lutto si reca al cimitero per porre dei fiori sulla tomba (vuota) del suo fidanzato caduto sul fronte. Un giorno si accorge di uno sconosciuto che a sua volta, di nascosto, svolge lo stesso pietoso rito: si tratta di Adrien, un francese (Pierre Niney), prima accolto con risentita ostilità dal padre e poi accettato da entrambi i genitori di Frantz, presso i quali lei ormai vive, per colmare di purissimo affetto il vuoto lasciato dall’amato.
La guerra (in)umana per il nomos
 Con il terzo episodio del prequel del Pianeta delle Scimmie si può scherzare. A patto, però, di farlo sul serio, come ogni gioco che si rispetti. È quanto mi accingo a fare, trattandolo come paratesto filosofico.
Con il terzo episodio del prequel del Pianeta delle Scimmie si può scherzare. A patto, però, di farlo sul serio, come ogni gioco che si rispetti. È quanto mi accingo a fare, trattandolo come paratesto filosofico.
Ti do i miei occhi di un tempo fa
 «[…] e allora è tempo di tenere degli appunti più piccoli sfalsati di 3 mesi e 3 giorni dalla data di inizio. Con tutta la costanza e tutta la speranza.»
«[…] e allora è tempo di tenere degli appunti più piccoli sfalsati di 3 mesi e 3 giorni dalla data di inizio. Con tutta la costanza e tutta la speranza.»
«È tempo» che il tempo inverta le sue coordinate, un tempo in cui le pagine di questo libro vengano sfogliate come si toccano i lembi di pelle prossimi a una lacerazione; perché il più delle volte l’azione che rimanda al gesto di apertura significa proprio questo: generare una ferita o «frantumare qualcosa, quindi, tutt’al più fare un’incisione, lacerare» (Didi-Huberman 2016, p.185) ché questo è un libro che trova la sua unità proprio in un’immagine colpita da frammenti, alla ricerca di un disvelamento sempre più prossimo ad una traccia d’iride, un solco.
Effetto Sherlock di Victor I. Stoichita: trappole dello sguardo.
 Victor I. Stoichita è un acuto storico d’arte romeno dal profilo internazionale, che persegue l’analisi di uno dei caratteri di fondo del cinema come arte visiva. La sua è del resto una parzialità di veduta, perché il “genere” cinematografico che egli affronta è – per sua natura – parziale, ancorché assai significativo: il racconto dell’investigazione criminale, derivante dal giallo. Nel suo insieme il noir è infatti particolarmente inquietante e largamente presente nell’immaginario diffuso dei poco più che 120 anni del film, e proviene direttamente, per Stoichita, dalla combinazione (pittorica) dell’impressionismo e (letteraria) del naturalismo.
Victor I. Stoichita è un acuto storico d’arte romeno dal profilo internazionale, che persegue l’analisi di uno dei caratteri di fondo del cinema come arte visiva. La sua è del resto una parzialità di veduta, perché il “genere” cinematografico che egli affronta è – per sua natura – parziale, ancorché assai significativo: il racconto dell’investigazione criminale, derivante dal giallo. Nel suo insieme il noir è infatti particolarmente inquietante e largamente presente nell’immaginario diffuso dei poco più che 120 anni del film, e proviene direttamente, per Stoichita, dalla combinazione (pittorica) dell’impressionismo e (letteraria) del naturalismo.
Immagini Mancanti. L’estetica del documentario nell’epoca dell’intermedialità
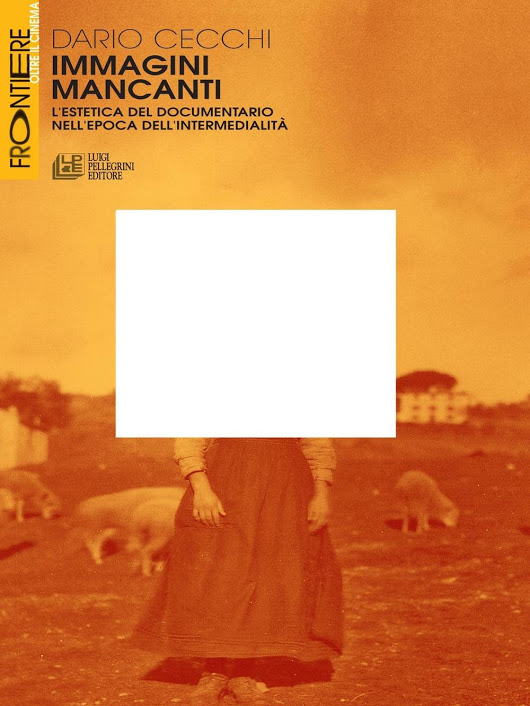 «Forse le definizioni storicamente più accreditate – documentario, documentario di creazione, cinema del reale – dovrebbero cedere il posto a una nuova denominazione, perché sempre più spesso facciamo esperienza di un cinema di testimonianza, nel quale l’istanza documentaria si mescola a una serie di altre istanze (etiche, politiche, narrative, rielaborative), richiedendo così che ne siano ripensati gli stessi presupposti» (p.20). Ma ciò che Dario Cecchi, studioso di filosofia e cinema, sviluppa nelle pagine del suo saggio non è una mappatura né una metodologia d’analisi, non fornisce formule interpretative nette né tantomeno si preoccupa di enucleare una possibile gamma delle tendenze.
«Forse le definizioni storicamente più accreditate – documentario, documentario di creazione, cinema del reale – dovrebbero cedere il posto a una nuova denominazione, perché sempre più spesso facciamo esperienza di un cinema di testimonianza, nel quale l’istanza documentaria si mescola a una serie di altre istanze (etiche, politiche, narrative, rielaborative), richiedendo così che ne siano ripensati gli stessi presupposti» (p.20). Ma ciò che Dario Cecchi, studioso di filosofia e cinema, sviluppa nelle pagine del suo saggio non è una mappatura né una metodologia d’analisi, non fornisce formule interpretative nette né tantomeno si preoccupa di enucleare una possibile gamma delle tendenze.
Rassegne
-
Registi fuori dagli ScheRmi
-
Registi fuori dagli ScheRmi II
-
Registi fuori dagli ScheRmi III
-
Registi fuori dagli scheRmi IV
-
Speciale Registi fuori dagli scheRmi IV
-
Registi fuori dagli scheRmi V
-
Speciale Registi fuori dagli scheRmi V
-
Registi fuori dagli scheRmi VI
-
Registi Fuori dagli ScheRmi VII
-
Registi fuori dagli Sche[r]mi VIII
-
Registi fuori dagli sche[r]mi IX
-
Registi fuori dagli sche[r]mi X
-
Registi fuori dagli scheRmi XI
-
immaginesomiglianza
-
Registi fuori dagli scheRmi XII
-
Registi fuori dagli scheRmi XIII
Archivio
- Uzak 50/51 | inverno/primavera 2026
- Uzak 48/49 | inverno/primavera 2025
- Uzak 46/47 | estate/autunno 2024
- Uzak 45 | inverno/primavera 2024
- Uzak 44 | estate/autunno 2023
- Uzak 43 | inverno/primavera 2023
- Uzak 42 | estate/autunno 2022
- UZAK 41 | inverno/primavera 2022
- Uzak 40 | estate / autunno 2021
- Uzak 39 | primavera 2021
- UZAK 38 | autunno 2020/ inverno 2021
- Uzak 37 | estate 2020
- Uzak 36 | primavera 2020
- Uzak 35 | autunno 2019 / inverno 2020
- Uzak 34 | estate 2019
- UZAK 33 | primavera 2019
- UZAK 32 | autunno 2018 - inverno 2019
- UZAK 30/31 | estate 2018
- UZAK 28/29 | autunno 2017 / inverno 2018
- UZAK 27 | estate 2017
- UZAK 26 | primavera 2017
- UZAK 24/25 | autunno/inverno 2016
- UZAK 23 | estate 2016
- UZAK 22 | primavera 2016
- UZAK 20/21 | autunno/inverno 2015
- UZAK 19 | estate 2015
- UZAK 18 | primavera 2015
- UZAK 16/17 | autunno/inverno 2014
- UZAK 15 | estate 2014
- UZAK 14 | primavera 2014
- UZAK 12/13 | autunno/inverno 2013
- UZAK 11 | estate 2013
- UZAK 10 | primavera 2013
- UZAK 09 | inverno 2013
- UZAK 07/08 | estate/autunno 2012
- UZAK 06 | primavera 2012
- UZAK 05 | inverno 2011
- UZAK 04 | autunno 2011
- UZAK 03 | estate 2011
- UZAK 02 | primavera 2011
- UZAK 01 | inverno 2010