 «I'm beggin' please, little lover, stop this carryin' on
«I'm beggin' please, little lover, stop this carryin' on
gotta get some lovin' before the planet is gone
A nuclear bomb come an' blow us all away
Come on, bad girl, give me some lovin' today»
(New York Dolls)
«Elle était belle à la fois de la beauté fugace d’une actrice et
de la beauté souveraine de la catastrophe»
(J. Gracq)
1. Dans le vide: (ipotesi immaginarie/revisioni dei pareri precedenti, shandysmo euristico vs paranoia critica, il filtro RWF, la metafisica Settanta, apodissi & apocalissi, la morte e il Simulacron 3, piangere con la Dietrich nel deserto)
È soprattutto negli esterni che questa caligine grigiastra si addensa, Veronika e Alexandre stanno in vaniloquio e come sotto assedio e appena dietro il parabrezza della Citroën c’è questo flusso di anti-materia fluida che li aspira verso il vuoto. Era il sole tremolante d’inizio primavera? Ora è come l’assalto di una sorta di nulla vibrante che sbatte contro i vetri, la lunga gonna coraggiosa di Bernadette Lafont si fa strada tra una Lancia in agonia e questo pulviscolo, si intravede poi oltre il riquadro come un succubo mosso, lanciato nell’acqua delle origini da lunga distanza, riverberato malamente dal retrovisore, solo le cose molto sagomate resistono all’invasione di questa luce floccolosa, riescono ancora a creare scie astratte che si possono seguire, schivando ciò che si muove, ciò che ancora continua ad agitarsi. Tutto sparirà. Ci sono i senhal e i segnacoli. Sono i viventi a disagio e in estinzione in questo b/n presago di tutte le fini di pista che verranno («la piste de goudron» che evoca Alexandre, la pista che si interrompe, archeologica come una piramide, funeraria come un antico ipogeo). Ecco perché c’è tutta una tassonomia di pose sdraiate e gauloises fumate davanti a invisibili e inesistenti dèi (Laforgue), nella vampa della veilleuse d’angolo. Queste pose da odalisca viziata, reminescenti gli ingres & i delacroix o i monet che emergono da brouillards di tenebra, volti femminili, inclinati in una mestizia primordiale, remigano su brume grigiastre verso un sempiterno, ritmico cut di campi svuotati, Parigi è prematuramente scomparsa in un florilegio di selciati qualsiasi e di androni inabitabili, continuamente interrotta da iris, dov’è finita la città? Perfino ai Deux Magots i volti si imprimono a stento in lunghi corridoi di campi medi à la Ozu e quando intercettano questa luce micidiale oscillano, accennano a dissolversi su qualche altra immagine che non vedremo, resistono e tremano inscritti su vetrate che danno sull’assenza, questi rettangoli sono i bordi di un cinema futuro che proietterà esclusivamente la pioggia corpuscolare perché alla fine tutto sarà finito e ci sarà solo una comunicazione medianica, ammesso che ci siano ancora i riceventi, parlare, parlare, Léaud sgrana il suo metodo morphèmico e entfremdet su questi testi pensatamente insulsi, parlare ancora per evitare che questa massa vibratile, che questa spuma nebbiosa entri dalle aperture e finisca di inghiottire tutto. (Nelle terrasses anche il traffico in presa diretta minaccia il parlato, vi si va a inserire con la sua massa sonora, opaca e amorfa, quasi una sorda risacca industrial destinata a fondersi, da sempre, audioicasticamente, con i dialoghi, sobillando ulteriormente la loro vacuità retorica).Veramente Eustache avrebbe messo in atto quest’estetica per raccontare una short story biografica di scarso interesse, per dare credito “ideologico” a questo blabla che al più possiede la grazia della stoltezza media in senso eliotiano? Che si potrà rileggere al contrario solo dopo aver annullato il suo senso demotico, quando verrà una sorta di Champollion psichedelico in grado di decifrarne il disagio, quando… Insomma tutto lo screenplay andrebbe riletto con tutte le ambiguità del caso, dove il testo acquisisce senso in situazione, aleatoriamente; un dramma da camera, non certo una dichiarazione d’intenti o una sorta di tractatus ideologico/logico. Ma cosa dice la critica? Un film straordinario etc ma réac, autobiografico, affresco “realistico” dell’epoca, una storia vera, epigonale rispetto alla Nouvelle Vague. Eustache nella sua disperazione di esteta romantico etc. E perché La Maman et La Putain sarebbe un film reazionario? Sì bellissimo ma reazionario. Perché Alexandre si fa beffe del PCF o di Sartre? Ma qualsiasi gauchiste, non solo G.-E. Debord, farebbe lo stesso, in quel momento storico (Sartre è il grande père da generazioni innombrables, chi è il giovane di turno che non lo abbia sbeffeggiato, dall’Arrache-cœur di Vian 50’s in avanti, è quasi un luogo comune). Per le battute un po’ stupide, in stile potache sul MLF? O per il lirismo sarcastico sull’aborto? O per la lunga sequenza, celeberrima su Françoise Lebrun/Veronika che riduce a niente le invocate libertà sessuali dai Movements? Per i figli e il lavoro reinstallati dopo tanto dandysmo progressivo? Per il finale bressoniano, vagamente Pickpocket? Ma se Eustache avesse semplicemente oggettivato dei personaggi? Facciamo una prima ipotesi a medio raggio, pronti a ritirarla un attimo dopo, tenendosi pronti per rilanci ulteriori, più interessanti, verrà il momento che ci giocheremo tutto, getteremo sul piatto solo l’improbabile. Non sarà un contrasto tra la classe operaia (Veronika) e una certa piccola-media borghesia hip e sovversiva (Alexandre)? Ci sono due classi sociali che non hanno a che fare con il cosiddetto Potere o non vogliono averci a che fare, un proletariato che non ha mai avuto contraintes sessuali (Freud dixit), che ha sempre goduto di una certa libertà pulsionale perché emancipato o privato di altri privilegi ma non “gode” davvero di questa libertà perché inquadrata nel più turpe e defaticante sfruttamento, appunto perché de-erotizzata, de-simbolizzata, pura débauche post-lavorativa. Veronika indubbiamente baise, plurima, mais dans le vide, e sogna il Simbolico nella figura del figlio, perché il sesso per lei non ha mai avuto altro senso che un’erranza baudelairiana (c’era già stato uno scrittore che aveva paragonato la vita precaria e senza storia del proletariato a quella descritta ne Les Fleurs du Mal). Dall’altra parte c’è una piccola/media borghesia inibita che sogna di affrancarsi da una certa psicotecnica che immola le libertà sessuali, le libertà in genere in vista dell’assunzione ieratica/austera di un ruolo dans le cadres, che accumula figli e amori come piccoli capitali rateizzabili, che vive una vita a dispense tragi/comicamente noiosissima. La rivendicazione della libertà, i salti logici surrealistici per mettere in crisi il razionalismo borghese, il rifiuto dell’amore come istituzione sovrastrutturale etc, saranno allora l’evidente lotto retorico di un Alexandre. Il film metterebbe in scena un chiasmo doloroso tra due classi che non possono capirsi, pur avendo tutto per intendersi, pur auspicando un’improbabile alleanza. E questo già nella stanchezza del post maggio ’68. Potrebbe anche essere, sì, potrebbe essere l’oggettivazione delle due anime di Eustache, l’ex-operaio delle ferrovie e il cinefilo. Insomma il romanticismo di Veronika perpetuerebbe il realismo di chi è condizionato dal bisogno, è un romanticismo inquinato dai punti fermi, dal concretismo più sfrenato, nel raddoppiamento dell’orario di lavoro, ognuno dei due continua il destino che vorrebbe schivare, Alexandre che, a colpi di bons mots e di attentati alla logica, prosegue nell’idealismo borghese e schivando una falsa vita ne assume un’altra non meno falsa, con tutte le ricadute nel più prevedibile sentimentalismo fino a quel matrimonio riparatore a cui sempre è stato vocato, per disciplina di classe. Ma già la critica ci direbbe di no, Eustache ha voluto semplicemente raccontare la sua vita, non ha voluto oggettivare niente, la critica comprova il tutto con le dichiarazioni di Eustache. Ha voluto parlare di un episodio particolarmente doloroso, scrivendovi una pièce para-teatrale per un film, lasciato da una donna e poi mantenuto da un’altra, si innamora di una terza, con tutta una serie di permutazioni poi nel jeu, con Françoise Lebrun che nella vita lo ha lasciato che viene chiamata sul set a interpretare la terza donna. E questo costa la vita a Catherine Garnier, la donna 2 nella cosiddetta realtà, la costumista sul set, la proprietaria dell’appartamento, che si suicida dopo aver visto in anteprima i rushes. Quindi i personaggi sono la sua vita e sono, evidentemente, i vessilliferi del suo pensiero. Si potrebbe obbiettare che l’ex-prolo Eustache è già stato sposato e con figli e che ha lasciato tutto per la grande avventura del cinema, dicendo che fino ad allora faceva una vita morne, una vita come tutti gli altri. Racconta questo con palmare orrore. E dopo si ricrederebbe e farebbe un film in cui si ravvede circa la necessità dei figli e del matrimonio? Ma la critica è inflessibile su questo punto, il film è un film autobiografico, lo comprovano anche gli amici o collaboratori, la stessa F. Le Brun, L. Beraud, il J. Douchet treccaniano che ha anche partecipato al film nel ruolo dell’uomo con gli abiti étriqués etc.
Ma cosa dice la critica? Un film straordinario etc ma réac, autobiografico, affresco “realistico” dell’epoca, una storia vera, epigonale rispetto alla Nouvelle Vague. Eustache nella sua disperazione di esteta romantico etc. E perché La Maman et La Putain sarebbe un film reazionario? Sì bellissimo ma reazionario. Perché Alexandre si fa beffe del PCF o di Sartre? Ma qualsiasi gauchiste, non solo G.-E. Debord, farebbe lo stesso, in quel momento storico (Sartre è il grande père da generazioni innombrables, chi è il giovane di turno che non lo abbia sbeffeggiato, dall’Arrache-cœur di Vian 50’s in avanti, è quasi un luogo comune). Per le battute un po’ stupide, in stile potache sul MLF? O per il lirismo sarcastico sull’aborto? O per la lunga sequenza, celeberrima su Françoise Lebrun/Veronika che riduce a niente le invocate libertà sessuali dai Movements? Per i figli e il lavoro reinstallati dopo tanto dandysmo progressivo? Per il finale bressoniano, vagamente Pickpocket? Ma se Eustache avesse semplicemente oggettivato dei personaggi? Facciamo una prima ipotesi a medio raggio, pronti a ritirarla un attimo dopo, tenendosi pronti per rilanci ulteriori, più interessanti, verrà il momento che ci giocheremo tutto, getteremo sul piatto solo l’improbabile. Non sarà un contrasto tra la classe operaia (Veronika) e una certa piccola-media borghesia hip e sovversiva (Alexandre)? Ci sono due classi sociali che non hanno a che fare con il cosiddetto Potere o non vogliono averci a che fare, un proletariato che non ha mai avuto contraintes sessuali (Freud dixit), che ha sempre goduto di una certa libertà pulsionale perché emancipato o privato di altri privilegi ma non “gode” davvero di questa libertà perché inquadrata nel più turpe e defaticante sfruttamento, appunto perché de-erotizzata, de-simbolizzata, pura débauche post-lavorativa. Veronika indubbiamente baise, plurima, mais dans le vide, e sogna il Simbolico nella figura del figlio, perché il sesso per lei non ha mai avuto altro senso che un’erranza baudelairiana (c’era già stato uno scrittore che aveva paragonato la vita precaria e senza storia del proletariato a quella descritta ne Les Fleurs du Mal). Dall’altra parte c’è una piccola/media borghesia inibita che sogna di affrancarsi da una certa psicotecnica che immola le libertà sessuali, le libertà in genere in vista dell’assunzione ieratica/austera di un ruolo dans le cadres, che accumula figli e amori come piccoli capitali rateizzabili, che vive una vita a dispense tragi/comicamente noiosissima. La rivendicazione della libertà, i salti logici surrealistici per mettere in crisi il razionalismo borghese, il rifiuto dell’amore come istituzione sovrastrutturale etc, saranno allora l’evidente lotto retorico di un Alexandre. Il film metterebbe in scena un chiasmo doloroso tra due classi che non possono capirsi, pur avendo tutto per intendersi, pur auspicando un’improbabile alleanza. E questo già nella stanchezza del post maggio ’68. Potrebbe anche essere, sì, potrebbe essere l’oggettivazione delle due anime di Eustache, l’ex-operaio delle ferrovie e il cinefilo. Insomma il romanticismo di Veronika perpetuerebbe il realismo di chi è condizionato dal bisogno, è un romanticismo inquinato dai punti fermi, dal concretismo più sfrenato, nel raddoppiamento dell’orario di lavoro, ognuno dei due continua il destino che vorrebbe schivare, Alexandre che, a colpi di bons mots e di attentati alla logica, prosegue nell’idealismo borghese e schivando una falsa vita ne assume un’altra non meno falsa, con tutte le ricadute nel più prevedibile sentimentalismo fino a quel matrimonio riparatore a cui sempre è stato vocato, per disciplina di classe. Ma già la critica ci direbbe di no, Eustache ha voluto semplicemente raccontare la sua vita, non ha voluto oggettivare niente, la critica comprova il tutto con le dichiarazioni di Eustache. Ha voluto parlare di un episodio particolarmente doloroso, scrivendovi una pièce para-teatrale per un film, lasciato da una donna e poi mantenuto da un’altra, si innamora di una terza, con tutta una serie di permutazioni poi nel jeu, con Françoise Lebrun che nella vita lo ha lasciato che viene chiamata sul set a interpretare la terza donna. E questo costa la vita a Catherine Garnier, la donna 2 nella cosiddetta realtà, la costumista sul set, la proprietaria dell’appartamento, che si suicida dopo aver visto in anteprima i rushes. Quindi i personaggi sono la sua vita e sono, evidentemente, i vessilliferi del suo pensiero. Si potrebbe obbiettare che l’ex-prolo Eustache è già stato sposato e con figli e che ha lasciato tutto per la grande avventura del cinema, dicendo che fino ad allora faceva una vita morne, una vita come tutti gli altri. Racconta questo con palmare orrore. E dopo si ricrederebbe e farebbe un film in cui si ravvede circa la necessità dei figli e del matrimonio? Ma la critica è inflessibile su questo punto, il film è un film autobiografico, lo comprovano anche gli amici o collaboratori, la stessa F. Le Brun, L. Beraud, il J. Douchet treccaniano che ha anche partecipato al film nel ruolo dell’uomo con gli abiti étriqués etc.
Ipotizziamo quindi qualcos’altro, qualcosa di falso, di completamente falso e liquidiamo l’ipotesi dell’oggettivazione come sbagliata, ma sbagliata soltanto per difetto. Non si tratta di interpretare, di oggettivare, ma di fare reagire altro per riaprire l’enigma Eustache, non aveva detto Wilde, The Critic as Artist, che il compito della critica sarebbe piuttosto quello di rendere ancora più misteriosa l’opera d’arte? Spiegare cosa? Piegare & ripiegare con cura una serie di false prospettive, ma tutte molto attraenti e perspicue. Ripartiamo quindi da Rainer Werner Fassbinder, inseriamo un filtro Fassbinder come un reagente possibile, 1971, ultimo film di produzione teatrale di RWF, antiteater-X-film, Warnung vor einer heiligen Nutte, girato in una falsa Iberia clownesca, in realtà a Sorrento, il suo film migliore in assoluto, il suo preferito sino alla fine e che la critica giudica tutt’al più un esercizio di stile o un film tardo Nouvelle Vague (ancora!). Quel meraviglioso vorticare ellissoidale 360° della mdp nella hall intorno alla colonna giallo cromo dopo che, ritualmente, innumerevoli, decollati, liberati in volo cuba libre si siano infranti sulle pareti pastello dell’hotel. Film/tourbillon incantevole e atroce. Qui Fassbinder in interni mostra un regista che stupra, seduce una troupe di asserviti, manipola a suo uso e consumo tutte le debolezze di ognuno, gioca sul bisogno di amore di ognuno. Sfrutta e viene sfruttato nel più classico jeu au massacre. È un film autobiografico, tutti lo testimoniano, già all’anti-teater RWF divideva e imperava, diventava il lacaniano piccolo oggetto a che tutti rincorrevano, porta sul set anche il leggendario perfecto brandiano che Ulli Lommel gli ha portato in dono da Parigi. Poi tardivamente, recently, c’è un intervista di Volker Schlöndorff che ha girato con lui un Baal televisivo (1970), film presto ritirato per l’ira di Helene Weigel che non sopporta la presenza oltraggiosa di RWF nella pièce di Brecht, gli utenti televisivi indirizzano petizioni perché la faccia di Fassbinder li spaventa. Quando il film viene riesumato (2012) Schlöndorff ipotizza che il Fassbinder/Baal avrebbe cambiato per sempre RWF, Fassbinder sarebbe diventato il Fassbinder seduttore/manipolatore che tutti ricordano dopo il Baal, è lì che avrebbe imparato come dominare gli altri («… Je me demande si le rôle ne l'a pas influencé. La manière dont Baal humilie… Emilie, la fille de l'entrepreneur, par exemple; plus tard, Fassbinder avait ce genre de comportement avec les membres de sa troupe: dès qu'il flairait une faiblesse chez quelqu'un, il enfonçait son poing dans la plaie jusqu'à ce que l'autre se soumette ou se révolte. Il voulait qu'il se révolte. Il disait : “Voilà, aie le courage d'être toi-même...”»). Cioè, se Schlöndorff ha ragione, Fassbinder avrebbe messo in scena se stesso biograficamente in un ruolo che avrebbe appreso dal cinema o dal teatro. Paradossale concetto di autobiografia. È il cinema una sorta di guardaroba archetipico di identità ovvero non esiste un’identità che precederebbe il set, meglio ancora, non esiste una vita che precederebbe il set. Come se il cinema fosse l’unica e vera realtà, una Porte de Clignancourt semi-metafisica dove giacciono non solo le giacche di pelle di dimenticati motociclisti ma anche tutte le identità potenziali, ready to wear, a poco prezzo e senza eccessiva responsabilità. Supponiamo che questo sia vero, che Schlöndorff abbia ragione, questo porterebbe a una lettura molto diversa del film. (In realtà sappiamo benissimo che ha ragione, ce lo dicono molte interviste successive di Fassbinder dove, quasi timidamente, confessa di aver dovuto incessantemente praticare un ruolo, fin dai tempi del teatro, fine anni Sessanta, di fronte al crollo dell’utopia della creazione collettiva, il ruolo del capo, anche del capo violento e inflessibile di fronte all’esigenza psichica degli altri di proiettare un’onnipotente figura parentale per potere “funzionare”, colpa dell’educazione autoritaria, segno ormai immodificabile su corpi e menti, dirà mestamente Fassbinder).
Ripartiamo quindi da Rainer Werner Fassbinder, inseriamo un filtro Fassbinder come un reagente possibile, 1971, ultimo film di produzione teatrale di RWF, antiteater-X-film, Warnung vor einer heiligen Nutte, girato in una falsa Iberia clownesca, in realtà a Sorrento, il suo film migliore in assoluto, il suo preferito sino alla fine e che la critica giudica tutt’al più un esercizio di stile o un film tardo Nouvelle Vague (ancora!). Quel meraviglioso vorticare ellissoidale 360° della mdp nella hall intorno alla colonna giallo cromo dopo che, ritualmente, innumerevoli, decollati, liberati in volo cuba libre si siano infranti sulle pareti pastello dell’hotel. Film/tourbillon incantevole e atroce. Qui Fassbinder in interni mostra un regista che stupra, seduce una troupe di asserviti, manipola a suo uso e consumo tutte le debolezze di ognuno, gioca sul bisogno di amore di ognuno. Sfrutta e viene sfruttato nel più classico jeu au massacre. È un film autobiografico, tutti lo testimoniano, già all’anti-teater RWF divideva e imperava, diventava il lacaniano piccolo oggetto a che tutti rincorrevano, porta sul set anche il leggendario perfecto brandiano che Ulli Lommel gli ha portato in dono da Parigi. Poi tardivamente, recently, c’è un intervista di Volker Schlöndorff che ha girato con lui un Baal televisivo (1970), film presto ritirato per l’ira di Helene Weigel che non sopporta la presenza oltraggiosa di RWF nella pièce di Brecht, gli utenti televisivi indirizzano petizioni perché la faccia di Fassbinder li spaventa. Quando il film viene riesumato (2012) Schlöndorff ipotizza che il Fassbinder/Baal avrebbe cambiato per sempre RWF, Fassbinder sarebbe diventato il Fassbinder seduttore/manipolatore che tutti ricordano dopo il Baal, è lì che avrebbe imparato come dominare gli altri («… Je me demande si le rôle ne l'a pas influencé. La manière dont Baal humilie… Emilie, la fille de l'entrepreneur, par exemple; plus tard, Fassbinder avait ce genre de comportement avec les membres de sa troupe: dès qu'il flairait une faiblesse chez quelqu'un, il enfonçait son poing dans la plaie jusqu'à ce que l'autre se soumette ou se révolte. Il voulait qu'il se révolte. Il disait : “Voilà, aie le courage d'être toi-même...”»). Cioè, se Schlöndorff ha ragione, Fassbinder avrebbe messo in scena se stesso biograficamente in un ruolo che avrebbe appreso dal cinema o dal teatro. Paradossale concetto di autobiografia. È il cinema una sorta di guardaroba archetipico di identità ovvero non esiste un’identità che precederebbe il set, meglio ancora, non esiste una vita che precederebbe il set. Come se il cinema fosse l’unica e vera realtà, una Porte de Clignancourt semi-metafisica dove giacciono non solo le giacche di pelle di dimenticati motociclisti ma anche tutte le identità potenziali, ready to wear, a poco prezzo e senza eccessiva responsabilità. Supponiamo che questo sia vero, che Schlöndorff abbia ragione, questo porterebbe a una lettura molto diversa del film. (In realtà sappiamo benissimo che ha ragione, ce lo dicono molte interviste successive di Fassbinder dove, quasi timidamente, confessa di aver dovuto incessantemente praticare un ruolo, fin dai tempi del teatro, fine anni Sessanta, di fronte al crollo dell’utopia della creazione collettiva, il ruolo del capo, anche del capo violento e inflessibile di fronte all’esigenza psichica degli altri di proiettare un’onnipotente figura parentale per potere “funzionare”, colpa dell’educazione autoritaria, segno ormai immodificabile su corpi e menti, dirà mestamente Fassbinder). E se questo avesse analogie con il caso Eustache? Ha messo la sua vita in La Maman? Quale vita? Quella di un cinefilo (disillusissimo circa la soi-disant vita sociale o biografica a cui crede poco o nulla), con tutta una serie di spostamenti e permutazioni ben diverse da quelle, acroamatiche e affichées, che credono i suoi interpreti. Se Léaud /Alexandre fosse p. ex. il Doinel truffautiano in una sorta di parodia tragica, painted black? Stabiliamo subito, semi-patafisicamente, che questo nuovo cinema dell’inizio degli anni Settanta non è epigonale alla Nouvelle Vague ma la nega, la sfotte, la insolentisce. C’è forse una sorta di parricidio in atto. Warnung è la parodia di Le Mépris e non un omaggio, RWF rovescia Godard (o Straub o Rohmer), il cinema non è un’arma progressiva ma un luogo di potere dove vittime e carnefici sono inestricabilmente uniti nella falsa coscienza. Dall’angeologia o mitologia Nouvelle Vague con i suoi luoghi aperti, magnificenti, i suoi scope, i suoi carrelli, il suo metacinema modernista, i suoi dialoghi programmatici che agglutinano le intenzioni del maker, i suoi Fritz Lang o J.S. Bach a impersonare l’artista che sfida il potere si passa a un’altra metafisica, lugubre, iper-illuminista dove non ci sono puri, né giusti ma dove ognuno sfruttatore/sfruttato lo è per posizione strutturale e inevitabile (Keiner Böse Keiner Gut, radiofonia fassbinderiana del ’72), dove si gira in luoghi chiusi, claustro-nyctalopici in maniera statica, dove si riapre con il già vituperato teatro, dove il testo è zeppo di nonsense e l’umore è nerissimo, dove i movimenti di macchina, la tipica trouvaille o infrazione grammaticale al cinema classico non è più modernismo costruttivista ma sberleffo, virtuosismo ulteriore nell’infilare sempre di più il film in una macchina di morte. Fassbinder è “polemico” verso l’elemento consolatorio della poetica Nouvelle Vague, la sua pretesa purezza, e non mette in scena se stesso ma semplicemente il cinema per quello che realmente è, en grossissant le trait, visto che è l’unico modo di vedere le cose, dirà poi, poco prima di morire. È un cinema totalmente illuminista come concezione che precipita di rimbalzo in una metafisica quasi plotinica, in una concezione ben più pessimista di quella di un Bresson. Nel cinema di RWF non ci sono cattivi, né buoni, se non posizionalmente, tutti però sono miserabili e infelici, è lo stesso in Eustache, Veronika non è Mouchette, si scontra con i propri infelici condizionamenti, con i presupposti degli altri e non è neppure il renoiriano «Le plus terrible dans ce monde est que chacun a ses raisons» de La Règle du Jeu. RWF e Eustache sono convinti che queste opposte ragioni siano tutte drammaticamente infondate, incubi che si confondono ad altri incubi del complessivo cattivo sueño sociale.
E se questo avesse analogie con il caso Eustache? Ha messo la sua vita in La Maman? Quale vita? Quella di un cinefilo (disillusissimo circa la soi-disant vita sociale o biografica a cui crede poco o nulla), con tutta una serie di spostamenti e permutazioni ben diverse da quelle, acroamatiche e affichées, che credono i suoi interpreti. Se Léaud /Alexandre fosse p. ex. il Doinel truffautiano in una sorta di parodia tragica, painted black? Stabiliamo subito, semi-patafisicamente, che questo nuovo cinema dell’inizio degli anni Settanta non è epigonale alla Nouvelle Vague ma la nega, la sfotte, la insolentisce. C’è forse una sorta di parricidio in atto. Warnung è la parodia di Le Mépris e non un omaggio, RWF rovescia Godard (o Straub o Rohmer), il cinema non è un’arma progressiva ma un luogo di potere dove vittime e carnefici sono inestricabilmente uniti nella falsa coscienza. Dall’angeologia o mitologia Nouvelle Vague con i suoi luoghi aperti, magnificenti, i suoi scope, i suoi carrelli, il suo metacinema modernista, i suoi dialoghi programmatici che agglutinano le intenzioni del maker, i suoi Fritz Lang o J.S. Bach a impersonare l’artista che sfida il potere si passa a un’altra metafisica, lugubre, iper-illuminista dove non ci sono puri, né giusti ma dove ognuno sfruttatore/sfruttato lo è per posizione strutturale e inevitabile (Keiner Böse Keiner Gut, radiofonia fassbinderiana del ’72), dove si gira in luoghi chiusi, claustro-nyctalopici in maniera statica, dove si riapre con il già vituperato teatro, dove il testo è zeppo di nonsense e l’umore è nerissimo, dove i movimenti di macchina, la tipica trouvaille o infrazione grammaticale al cinema classico non è più modernismo costruttivista ma sberleffo, virtuosismo ulteriore nell’infilare sempre di più il film in una macchina di morte. Fassbinder è “polemico” verso l’elemento consolatorio della poetica Nouvelle Vague, la sua pretesa purezza, e non mette in scena se stesso ma semplicemente il cinema per quello che realmente è, en grossissant le trait, visto che è l’unico modo di vedere le cose, dirà poi, poco prima di morire. È un cinema totalmente illuminista come concezione che precipita di rimbalzo in una metafisica quasi plotinica, in una concezione ben più pessimista di quella di un Bresson. Nel cinema di RWF non ci sono cattivi, né buoni, se non posizionalmente, tutti però sono miserabili e infelici, è lo stesso in Eustache, Veronika non è Mouchette, si scontra con i propri infelici condizionamenti, con i presupposti degli altri e non è neppure il renoiriano «Le plus terrible dans ce monde est que chacun a ses raisons» de La Règle du Jeu. RWF e Eustache sono convinti che queste opposte ragioni siano tutte drammaticamente infondate, incubi che si confondono ad altri incubi del complessivo cattivo sueño sociale. Warnung, ripetiamolo, è un film “contro” Straub, “contro” Godard, con la loro pretesa di fare un cinema politico, di fare un cinema che sia puro. Non esiste, dice RWF, un cinema politico che non mostri il cinema come oggetto impuro ab origine, come oscena macchina di morte, non si può fare un discorso sul cinema che ignori il suo triste côté aziendale. Vani sono i tentativi di Godard di riferire il cinema ad altre arti, di nobilitarlo o addirittura di ostenderlo come la summa delle arti precedenti, fare cinema non è esattamente la stessa cosa che scrivere libri in solitudine, comporta inevitabilmente lo sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo (aveva già compendiato anni prima Orson Welles, a Playboy, il regista di cinema è un great bastard). RWF liquida ritualmente i suoi antichi maestri (nella loro classica posizione di Über-Ich per tutti i cineasti della sua generazione), si emancipa dalle loro teorie, indica il verso oscuro, strutturale del cinema. La magnifica scena dei gerani dove RWF mima non soltanto Le Mépris ma forse anche altri film mediterranei dei 60’s (forse un semi-geniale filmaccio di Chabrol, La Route de Corinthe, 1967, pura perfidia alimentare in stile infantile e tardogodardiano): gruppi di attori che si dispiegano a cuspidi geometriche lungo lo snodo a S di muretti sormontati da enormi vasi. Il mare rimane lontanissimo e fuori gioco, tutto meno che mitologico, composizione virtuosistica di gusto impeccabile con rapporti figura/sfondo magnifici che dimostrano quanto RWF abbia imparato da certi registi, arcano figurativo che si rompe/si scioglie sull’urlo dell’heilige Nutte, del regista Jeff/Lou Castel. RWF indicativamente si fa rappresentare nel ruolo di santa puttana del cinema da un attore che notoriamente odia e disprezza i set, che continua a girare solo per finanziare gli extraparlamentari (partito dal laboratorio Fersen e dalle trances africane dichiarerà a Paese Sera che il metodo Stanislavskij serve solo a rendere l’attore subalterno al regista), quello che è certo è che Fassbinder non fa niente per smorzare lo scherno incontrollato di Castel che riempie quasi psicodrammaticamente tutto il film. Jeff si scaglia istericamente sull’impostura del ruolo del cosiddetto artista, in realtà un volgare imprenditore, un maquereau che si crede un artefice. La Maman et La Putain non sarà, a sua volta, un film “contro” Truffaut? Détournando Léaud, smascherando finalmente tutto il piccolo sadismo consolatorio che si annida dietro il personaggio archetipico Doinel, autentico grumo di significanza o, più banalmente, idea confortante che di sé vuole avere una certa piccola-media borghesia per credersi branché, un film contro le virtù patetiche di un certo cinema francese, sui buoni sentimenti triangolari, un Domicile Conjugal dipinto di nero dove mostrare quale inferno siano i sentimenti, quale circuito di violenza li sostenga. Un Ai no Corrῑda dei sentimenti, un oshimismo implacabile (non un barthesismo/stendhalismo delle cristallizzazioni) dove i sentimenti sono la continuazione della guerra dei ruoli e dei condizionamenti sociali, dell’immaginario animale, con altri mezzi, fino alla fine, fino all’annientamento dell’altro e di sé. Fino a che degli amanti restino solo le canzoni, circolarmente, in percorso di cenere e natura morta, come ne Les Amants de Paris di Piaf che Bernadette Lafont/Marie, abbandonata a 10’ dalla fine, orizzontale come una linea, intersecata malamente dal cono corpuscolare della veilleuse, ascolta integralmente fino al taglio sulla Citroën che Alexandre parcheggia\seppellisce in una remota zona onirica. Beacoup plus loin que le réel direbbe Alix Cléo Roubaud (amica di Eustache, creatrice di una poetica della scomparsa e che considera la fotografia un’esthétique de la ruine, finirà per essere testimone acustica del suo suicidio, risvegliata da quel colpo di pistola nella notte).
Warnung, ripetiamolo, è un film “contro” Straub, “contro” Godard, con la loro pretesa di fare un cinema politico, di fare un cinema che sia puro. Non esiste, dice RWF, un cinema politico che non mostri il cinema come oggetto impuro ab origine, come oscena macchina di morte, non si può fare un discorso sul cinema che ignori il suo triste côté aziendale. Vani sono i tentativi di Godard di riferire il cinema ad altre arti, di nobilitarlo o addirittura di ostenderlo come la summa delle arti precedenti, fare cinema non è esattamente la stessa cosa che scrivere libri in solitudine, comporta inevitabilmente lo sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo (aveva già compendiato anni prima Orson Welles, a Playboy, il regista di cinema è un great bastard). RWF liquida ritualmente i suoi antichi maestri (nella loro classica posizione di Über-Ich per tutti i cineasti della sua generazione), si emancipa dalle loro teorie, indica il verso oscuro, strutturale del cinema. La magnifica scena dei gerani dove RWF mima non soltanto Le Mépris ma forse anche altri film mediterranei dei 60’s (forse un semi-geniale filmaccio di Chabrol, La Route de Corinthe, 1967, pura perfidia alimentare in stile infantile e tardogodardiano): gruppi di attori che si dispiegano a cuspidi geometriche lungo lo snodo a S di muretti sormontati da enormi vasi. Il mare rimane lontanissimo e fuori gioco, tutto meno che mitologico, composizione virtuosistica di gusto impeccabile con rapporti figura/sfondo magnifici che dimostrano quanto RWF abbia imparato da certi registi, arcano figurativo che si rompe/si scioglie sull’urlo dell’heilige Nutte, del regista Jeff/Lou Castel. RWF indicativamente si fa rappresentare nel ruolo di santa puttana del cinema da un attore che notoriamente odia e disprezza i set, che continua a girare solo per finanziare gli extraparlamentari (partito dal laboratorio Fersen e dalle trances africane dichiarerà a Paese Sera che il metodo Stanislavskij serve solo a rendere l’attore subalterno al regista), quello che è certo è che Fassbinder non fa niente per smorzare lo scherno incontrollato di Castel che riempie quasi psicodrammaticamente tutto il film. Jeff si scaglia istericamente sull’impostura del ruolo del cosiddetto artista, in realtà un volgare imprenditore, un maquereau che si crede un artefice. La Maman et La Putain non sarà, a sua volta, un film “contro” Truffaut? Détournando Léaud, smascherando finalmente tutto il piccolo sadismo consolatorio che si annida dietro il personaggio archetipico Doinel, autentico grumo di significanza o, più banalmente, idea confortante che di sé vuole avere una certa piccola-media borghesia per credersi branché, un film contro le virtù patetiche di un certo cinema francese, sui buoni sentimenti triangolari, un Domicile Conjugal dipinto di nero dove mostrare quale inferno siano i sentimenti, quale circuito di violenza li sostenga. Un Ai no Corrῑda dei sentimenti, un oshimismo implacabile (non un barthesismo/stendhalismo delle cristallizzazioni) dove i sentimenti sono la continuazione della guerra dei ruoli e dei condizionamenti sociali, dell’immaginario animale, con altri mezzi, fino alla fine, fino all’annientamento dell’altro e di sé. Fino a che degli amanti restino solo le canzoni, circolarmente, in percorso di cenere e natura morta, come ne Les Amants de Paris di Piaf che Bernadette Lafont/Marie, abbandonata a 10’ dalla fine, orizzontale come una linea, intersecata malamente dal cono corpuscolare della veilleuse, ascolta integralmente fino al taglio sulla Citroën che Alexandre parcheggia\seppellisce in una remota zona onirica. Beacoup plus loin que le réel direbbe Alix Cléo Roubaud (amica di Eustache, creatrice di una poetica della scomparsa e che considera la fotografia un’esthétique de la ruine, finirà per essere testimone acustica del suo suicidio, risvegliata da quel colpo di pistola nella notte).
Renoir credeva che le ragioni dei tutti fossero valide o fondate, per quanto oppositive. Eustache crede invece che queste ragioni siano condizionate, nascano già condizionate da un meccanismo sociale, siano insomma finzioni teatrali, è la vita ad essere falsa mentre il cinema dice la verità, una verità di morte, una mise en abyme di questa finzione. Sarà per questo che RWF dice che l’amore è più freddo della morte ma che il cinema è più caldo della vita (Liebe ist kälter als der Tod aber das Kino ist wärmer als das Leben, 1969). A Saint-Germain-de-Prés ci sono migliaia di Alexandre che circolano dopo l’urto del Maggio, il potere ha vacillato metafisicamente, il gaullismo, la Francia, il vecchio clerico/fascismo italiano sono carta straccia a livello simbolico, si poggiano solo dans le vide (come gli amplessi mortificanti che vive Veronika/Lebrun) ma resistono come bisogno, bisogno imperativo strutturale. E sia Eustache che RWF denunciano questo, la denuncia più terrificante, il bisogno di potere che c’è negli individui, bisogno di rimettere la propria vita in mano di altri, con tutte le buone, tragiche ragioni possibili. Se il potere si scopre senza fondamento alcuno per giustificare la sua esistenza, la sua critica giunge a sua volta a qualcosa di invalicabile, è stato toccato un limite, un vero e proprio punto cieco. Non basta neppure più soddisfare certi bisogni, ci vorrebbe un salto qualitativo, assente è la fantasia, come un dio di fantascienza che potrebbe rovesciare la logica, per ora si vedono solo le mura invalicabili del certo. Allora se la fantasia è indisponibile le terranno luogo la follia e l’ebbrezza. La Storia esplode, gettata a terra di malagrazia come un vecchio salvadanaio, sono solo reliquie di poco valore, forse solo uno splendido trovarobato teatrale. Sarà indubbiamente vero che, come dicono i Movements, il potere induce bisogni falsi, ma è certo che questo falso è sempre abilmente mescolato, il potere avvolge in confezione il falso con i nostri bisogni più naturali, la paura di restare soli, l’eternità biologica (i figli, il futuro) e su questa base conforta, nutre, protegge. È qui che Eustache è dandy, pur nel più spietato realismo, l’ultima e terminale stazione del dandy, il rifiuto di ogni logica naturale. Non è dandy nel senso di Alexandre. Ci sono migliaia di Alexandre qui flanent a Parigi nel ‘72-‘73, con le cravates-foulards, i bei completi Seventies does Thirties, con la loro bibliografia para-surrealista in tasca, si vedono in tutti i film del periodo, già però nel gouffre di un neo-sentimentalismo, già pronti a inciampare nell’impiego o scivolabili con qualche orrore d’espiazione in un Le Diable probablement (1977) già a chiusura di decennio. Quello che Eustache decide di filmare non è certo la storia singolare ma quasi il paradigma del flâneur parigino epocale, disilluso, passato quasi come conseguenza logica dal gauchisme a una sorta di dandysmo perché constata la realtà come irredimibile. Anni dopo RWF dirà che molti non si erano più ripresi dopo il primo terrificante insight post ’68: le cose non sarebbero cambiate tanto facilmente, tra migliaia di anni forse, forse mai, lui diceva di essersi salvato descrivendo, descrivendo freddamente la realtà per come è, senza proiezioni o speranze. Il mondo (sociale) si tinge di scuro, assume questa livrea, come un pesce delle profondità per mescolarsi meglio con una Storia periclitante ormai nei più estremi fondali, quando tutte le sue uscite si sono rivelate chiuse, forse per sempre. Il Nevermore è molto di moda, l’ultima moda (Doom or Mood?).
A Saint-Germain-de-Prés ci sono migliaia di Alexandre che circolano dopo l’urto del Maggio, il potere ha vacillato metafisicamente, il gaullismo, la Francia, il vecchio clerico/fascismo italiano sono carta straccia a livello simbolico, si poggiano solo dans le vide (come gli amplessi mortificanti che vive Veronika/Lebrun) ma resistono come bisogno, bisogno imperativo strutturale. E sia Eustache che RWF denunciano questo, la denuncia più terrificante, il bisogno di potere che c’è negli individui, bisogno di rimettere la propria vita in mano di altri, con tutte le buone, tragiche ragioni possibili. Se il potere si scopre senza fondamento alcuno per giustificare la sua esistenza, la sua critica giunge a sua volta a qualcosa di invalicabile, è stato toccato un limite, un vero e proprio punto cieco. Non basta neppure più soddisfare certi bisogni, ci vorrebbe un salto qualitativo, assente è la fantasia, come un dio di fantascienza che potrebbe rovesciare la logica, per ora si vedono solo le mura invalicabili del certo. Allora se la fantasia è indisponibile le terranno luogo la follia e l’ebbrezza. La Storia esplode, gettata a terra di malagrazia come un vecchio salvadanaio, sono solo reliquie di poco valore, forse solo uno splendido trovarobato teatrale. Sarà indubbiamente vero che, come dicono i Movements, il potere induce bisogni falsi, ma è certo che questo falso è sempre abilmente mescolato, il potere avvolge in confezione il falso con i nostri bisogni più naturali, la paura di restare soli, l’eternità biologica (i figli, il futuro) e su questa base conforta, nutre, protegge. È qui che Eustache è dandy, pur nel più spietato realismo, l’ultima e terminale stazione del dandy, il rifiuto di ogni logica naturale. Non è dandy nel senso di Alexandre. Ci sono migliaia di Alexandre qui flanent a Parigi nel ‘72-‘73, con le cravates-foulards, i bei completi Seventies does Thirties, con la loro bibliografia para-surrealista in tasca, si vedono in tutti i film del periodo, già però nel gouffre di un neo-sentimentalismo, già pronti a inciampare nell’impiego o scivolabili con qualche orrore d’espiazione in un Le Diable probablement (1977) già a chiusura di decennio. Quello che Eustache decide di filmare non è certo la storia singolare ma quasi il paradigma del flâneur parigino epocale, disilluso, passato quasi come conseguenza logica dal gauchisme a una sorta di dandysmo perché constata la realtà come irredimibile. Anni dopo RWF dirà che molti non si erano più ripresi dopo il primo terrificante insight post ’68: le cose non sarebbero cambiate tanto facilmente, tra migliaia di anni forse, forse mai, lui diceva di essersi salvato descrivendo, descrivendo freddamente la realtà per come è, senza proiezioni o speranze. Il mondo (sociale) si tinge di scuro, assume questa livrea, come un pesce delle profondità per mescolarsi meglio con una Storia periclitante ormai nei più estremi fondali, quando tutte le sue uscite si sono rivelate chiuse, forse per sempre. Il Nevermore è molto di moda, l’ultima moda (Doom or Mood?).
«…le dernier film: dans ce mot la mode et la mort se joignent: dernier en date mais aussi y en aura-t-il un autre? La mort est la plus moderne des choses…» dirà Jean-Jacques Schuhl proprio in tempo, 1972 (qui la critica avrebbe ragione se indicasse nei suoi test il pendant teorico-poetico del film di Eustache ma se così fosse dovrebbe rinunciare all’idea di autobiografismo, Rose Poussière è un vero trattato di de-personalizzazione, sovversivo).
Sincronicamente YSL proclama morta la Couture (ha sempre supremamente odiato la signora borghese, ha sempre sognato di fare il beatnik) e inaugura la scandalosa Occupation del ’71, viene accusato di essersi ispirato al glamour lascivo delle collaborazioniste e delle mantenute della Gestapo, lui dichiarerà di aver voluto fare riflettere. Eserciterà un’enorme influenza anche sul cinema, di evidente influenza saint-laurentiana sono gli abiti della costumista italiana Naselli-Rocca per Mr Klein (1976), Losey chiede a lei e allo scenografo, l’ex-carnéiano Alexander Trauner di non storicizzare troppo, piuttosto di tradurre, Losey tende in pratica a sovrapporre la Francia pompidoulienne dei 70’s a quella vichyssoise dei 40’s.  Circola evidentemente un’aria sinistra (forse solo gli straordinari film di Jacques Rivette capiscono che il complotto va giocato su un altro piano, propongono una deriva, un’evasione maya in altri continenti psichici). Addirittura Bertolucci potrebbe centrare il bersaglio con la sua storia di due falliti che vengono devastati dalla lettura ad alto potenziale di un Bataille male inteso («Spectre en larmes / ô dieu mort/ œil cave/ moustache humide/ ô dieu mort/ je te porsuivais/ de haine insondabile…»), ma le citazioni liminari di Francis Bacon visto al Grand Palais rimangono esclusivamente programmatiche e, per quanto spinga i suoi personaggi dentro la couleur tango del suo capo-operatore non riesce a comporre una vera astrazione, gli manca la profondità metafisica di Eustache, si dovrà accontentare di piacere a Pauline Kael (rimane solo quel chewing-gum esistenziale che Brando appiccica in morte sotto il corrimano dell’aurora, probabile idea dello stesso Brando, nel furore sprezzante che dedica a ogni personaggio). Eppure anche lì il Léaud cinefilo potrebbe essere il gemello stolto di Alexandre, circola nelle stesse strade, parodizzato nei suoi esercizi di stile para-dandystici e indossante lo stesso crop d’aviazione che Truffaut sfoggia ne La nuit Américaine. No, Eustache non filma davvero una storia privata, Alexandre è piuttosto uno specimen. Eustache è dandy solo perché crede nella déchéanche («je bois, je bois»), perché crede nello iato, nella catastrofe, perché crede nel bisogno falso cioè inventato perché è l’unica esperienza di libertà possibile. Ma non è facile trovare davvero un bisogno falso, è irraggiungibile come la libertà o la déchéance, questo dice Eustache, in uno dei suoi paradossi non compresi. Perché il cinema apocalittico potrebbe aprire finalmente a un rovesciamento di presupposti, liberare l’erotismo e non il sesso, la morte e non la vita, il sogno e non la realtà, aprire finalmente la scatola nera di quello che ci ha fatti essere così (dipendenti, sempre, sadici, sempre, infelici, sempre) e non altrimenti. Provocare una metamorfosi che diabolicamente transiti perpendicolare a questo grande urto (il «la catastrophe est la révolution plus profonde» de L’Expérience intérieure). E il senso di tutto questo, il cinema disperato, realistico, quindi pessimista, e di rimbalzo in rimbalzo alogico, apocalittico o metafisico, si potrebbe trovare ancora in un altro film di Fassbinder. Un film di cui la critica si sdilinque a dire che Fassbinder avrebbe antiveduto la realtà virtuale. Invece è evidentemente un film sul concetto di autobiografia, sulla sua fine. Un film di fantascienza che gira per la tv nel 1973, Welt am Draht: un programmatore di realtà virtuale (una realtà abitata da gente che crede di essere viva, di poter decidere, di avere un passato “suo”, un vero e proprio universo sociale chiamato Simulacron 3).
Circola evidentemente un’aria sinistra (forse solo gli straordinari film di Jacques Rivette capiscono che il complotto va giocato su un altro piano, propongono una deriva, un’evasione maya in altri continenti psichici). Addirittura Bertolucci potrebbe centrare il bersaglio con la sua storia di due falliti che vengono devastati dalla lettura ad alto potenziale di un Bataille male inteso («Spectre en larmes / ô dieu mort/ œil cave/ moustache humide/ ô dieu mort/ je te porsuivais/ de haine insondabile…»), ma le citazioni liminari di Francis Bacon visto al Grand Palais rimangono esclusivamente programmatiche e, per quanto spinga i suoi personaggi dentro la couleur tango del suo capo-operatore non riesce a comporre una vera astrazione, gli manca la profondità metafisica di Eustache, si dovrà accontentare di piacere a Pauline Kael (rimane solo quel chewing-gum esistenziale che Brando appiccica in morte sotto il corrimano dell’aurora, probabile idea dello stesso Brando, nel furore sprezzante che dedica a ogni personaggio). Eppure anche lì il Léaud cinefilo potrebbe essere il gemello stolto di Alexandre, circola nelle stesse strade, parodizzato nei suoi esercizi di stile para-dandystici e indossante lo stesso crop d’aviazione che Truffaut sfoggia ne La nuit Américaine. No, Eustache non filma davvero una storia privata, Alexandre è piuttosto uno specimen. Eustache è dandy solo perché crede nella déchéanche («je bois, je bois»), perché crede nello iato, nella catastrofe, perché crede nel bisogno falso cioè inventato perché è l’unica esperienza di libertà possibile. Ma non è facile trovare davvero un bisogno falso, è irraggiungibile come la libertà o la déchéance, questo dice Eustache, in uno dei suoi paradossi non compresi. Perché il cinema apocalittico potrebbe aprire finalmente a un rovesciamento di presupposti, liberare l’erotismo e non il sesso, la morte e non la vita, il sogno e non la realtà, aprire finalmente la scatola nera di quello che ci ha fatti essere così (dipendenti, sempre, sadici, sempre, infelici, sempre) e non altrimenti. Provocare una metamorfosi che diabolicamente transiti perpendicolare a questo grande urto (il «la catastrophe est la révolution plus profonde» de L’Expérience intérieure). E il senso di tutto questo, il cinema disperato, realistico, quindi pessimista, e di rimbalzo in rimbalzo alogico, apocalittico o metafisico, si potrebbe trovare ancora in un altro film di Fassbinder. Un film di cui la critica si sdilinque a dire che Fassbinder avrebbe antiveduto la realtà virtuale. Invece è evidentemente un film sul concetto di autobiografia, sulla sua fine. Un film di fantascienza che gira per la tv nel 1973, Welt am Draht: un programmatore di realtà virtuale (una realtà abitata da gente che crede di essere viva, di poter decidere, di avere un passato “suo”, un vero e proprio universo sociale chiamato Simulacron 3).
Anche qui elementi biografici, con Karl Löwitsch che gira in gelidi parking sotterranei con la Corvette Mako Shark (o è una Manta Ray?) di proprietà di Fassbinder, che corre a portare un po’ di Gone in 60 Seconds (1974) per gli agghiaccianti chalets della Bassa Baviera. È stato detto che il film esprime il rapporto tra film e realtà, ed è verissimo. Sfugge il giudizio definitivo che Fassbinder esprime nei confronti dell’identità o della biografia personale: sembrerebbe dire che da quando nasciamo non siamo altro che un programma di condizionamenti, un’assunzione strutturale di ruolo in situazione, niente di meno personale della propria storia, solo un immenso trauma o traum da cui è quasi impossibile risvegliarsi perché l’elemento centrale di questo succubo identitario è il potere, l’illusione di potere a sua volta coercire o creare destini. Anche la vittima o il disagiato partecipa di questo, perché continua a credere fermamente che questo destino sia il suo, si va dunque a porre in mesmerismo sociale o in triangolo amoroso girardiano con il carnefice, suo doppio strutturale o hypocrite frère (in parole, in catene). Solo una disperazione estrema (o una sfrenata malinconia secondo Eustache) permettono di sfuggire alla cosiddetta biografia, una sorta di carcere psichico-progettuale, un programma che è un segno delle violenze subite (RWF dirà che il corpo deve capire la morte perché i progetti sono solo quelli del potere, il corpo deve arrestare il tempo per uscire dal tempo del potere, l’epoca deve trascendere l’epoca). Gongoristicamente el infierno vencer con el infierno. E se il dandysmo non è quello Bulwer-Lytton, degli esponenti (antipatici) di una certa classe (antipatica), non può essere che un appuntamento con il negativo, solo la caduta permette la rottura della logica, la suprema astrazione, solo quando il fittizio non è più un’illusione manierata ma un passaggio a un exitus inevitabile c’è la conquista dell’altra dimensione, sigmundianamente l’Altra Scena, forse per un solo istante la déchéance è l’Aldilà; Brummel forse diventa dandy solo a Caen quando imbandisce per gli spettri in abiti Reggenza, Wilde quando all’Hotel d’Alsace vive-muore finalmente al di sopra dei propri mezzi.
Solo una disperazione estrema (o una sfrenata malinconia secondo Eustache) permettono di sfuggire alla cosiddetta biografia, una sorta di carcere psichico-progettuale, un programma che è un segno delle violenze subite (RWF dirà che il corpo deve capire la morte perché i progetti sono solo quelli del potere, il corpo deve arrestare il tempo per uscire dal tempo del potere, l’epoca deve trascendere l’epoca). Gongoristicamente el infierno vencer con el infierno. E se il dandysmo non è quello Bulwer-Lytton, degli esponenti (antipatici) di una certa classe (antipatica), non può essere che un appuntamento con il negativo, solo la caduta permette la rottura della logica, la suprema astrazione, solo quando il fittizio non è più un’illusione manierata ma un passaggio a un exitus inevitabile c’è la conquista dell’altra dimensione, sigmundianamente l’Altra Scena, forse per un solo istante la déchéance è l’Aldilà; Brummel forse diventa dandy solo a Caen quando imbandisce per gli spettri in abiti Reggenza, Wilde quando all’Hotel d’Alsace vive-muore finalmente al di sopra dei propri mezzi.
No, La Maman et la Putain non è un film biografico, réac, che preferisce il matrimonio alle libertà sessuali, è un film che le mostra come permutazioni del matrimonio, è un film che mostra come non si sfugga alla struttura di violenza che regola i rapporti umani, propone un’analisi fantasmatica dei limiti dell’immaginario, un’apocalissi e una sua metafisica specifica. Eustache aderisce al monologo di Veronika solo come linguaggio emozionale, in situazione. RWF parlerà sempre della propria identificazione con il lumperprolet berlinese Frank Biberkopf, il personaggio di Döblin. Ma è un’identificazione ideologica? Quando in Berlin Alexanderplatz Franz urla, nella scena dei topi, che l’uomo è l’animale più immondo, forse la più intensa di tutto il film, mentre dall’impiantito sale, beffarda come un inno, nichilisticamente kraftwerkica, Radioactivity a diminuire/aumentare l’intransigenza di quel giudizio, lì RWF si identifica ideologicamente con il personaggio? Lo stesso anno in cui, poco più tardi un’intervista ai Cahiers dirà che crede agli ideali di anarchismo settecentesco e alla fine della società delle classi e nella fondamentale redimibilità dell’uomo, quasi rousseauiano? O forse c’è differenza tra un linguaggio delle emozioni e un linguaggio teoretico? L’adesione di RWF è per chi non ha filtri per sentire tutto il dolore della violenza dell’uomo sull’uomo e può esprimersi solo così, come potrebbe parlare altrimenti un Frank Biberkopf? Eustache aderisce al discorso di Veronika non ideologicamente ma amorosamente, è la simpatia per una povera proletaria infinitamente violentata dai rapporti di forza che nessun editto ideologico può sciogliere, una donna che, a sua maniera, parlando di figli, invoca una sorta di trascendenza, un dio che non c’è, un dopo che non c’è. Una Veronika, a sua volta, che solo così può esprimersi e non altrimenti. Eustache aderisce a questo pianto connotativo, non alla sua lettera che è morta nel momento stesso di pronunciarsi. Le lacrime sono l’ultima parola. Nel quadro di un film che parla di singolarità storiche così precise che alla fine diventano allegoriche, fino a diventare una sorta di auto sacramental dove tutto ciò che si mostra deve essere trasceso. Dov’è la liberazione? C’è un’immagine che plana sul suo p/p in lacrime, sul suo abito di tulle, sulla sua scriminatura, cosa dice l’ex-attrice di vaudeville Falconetti all’attore avant-garde Artaud («e la liberazione?»)? Lei dondola la testa come Veronika, sempre inseguire per un attimo il pensiero e allontanarsi dall’estasi, poi ritorna radiosa e guarda verso l’oltre del set, la morte, solo la morte, il realismo superiore direbbe Dreyer (o anche qui il linguaggio emozionale andrebbe trasvalutato in salto logico, oltre la logica? Non lo sapremo mai). La morte. Nevermore.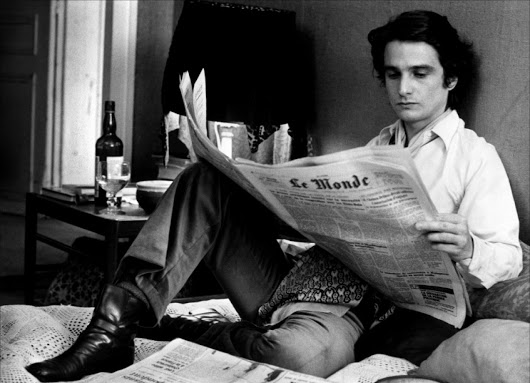 E perché la critica non lo capisce? La critica non può pensare la morte, perché è uno strumento ciclico? Perché si ricarica, perché è fatta per le repliche? La critica è puritana perché non può pensare la morte dunque non può pensare l’orgasmo (di senso, se non dei sensi)? I suoi messaggi saranno sempre e soltanto edificanti, il definitivo, l’estasi sempre mancante? I critici sono dei chierici in guardia contro ogni jouissance, impediscono la morte del cinema, la sua ultima estasi? La critica è triste ma non malinconica? La critica recupera, non spreca niente?
E perché la critica non lo capisce? La critica non può pensare la morte, perché è uno strumento ciclico? Perché si ricarica, perché è fatta per le repliche? La critica è puritana perché non può pensare la morte dunque non può pensare l’orgasmo (di senso, se non dei sensi)? I suoi messaggi saranno sempre e soltanto edificanti, il definitivo, l’estasi sempre mancante? I critici sono dei chierici in guardia contro ogni jouissance, impediscono la morte del cinema, la sua ultima estasi? La critica è triste ma non malinconica? La critica recupera, non spreca niente?
È un cinema invece che vede, sogna con chiarezza la fine del cinema, proprio nella prima metà degli anni Settanta, prima che rapporti produttivi diversi, prima che una borghesia ancora più volgare delle altre ne prenda in mano le redini, prima soprattutto che un’immane miriade d’immagini ne prenda il posto per sempre, privando il cinema di quella cornice che era essenziale per il suo avvento o evento. Il cinema svanirà, morirà, poco dopo, sepolto per sempre sotto un’infinità di eidola fuori di ogni cardine, dove è ormai solo un residuo funebre di una vecchia liturgia dimenticata. Alexandre vede questo dopo lo scontro con il garde-rail, al termine della pista di catrame c’è la fine anche del cinema, la fine di tutti i progetti e alla fine si smette di andare da qualche parte, non c’è più un posto dove andare. È una sorta di Annabel Lee obliata in châssis, un’Annabel Lee che avrà in sorte di essere recuperata per un improbabile ultimo giorno o che, al contrario, verrà condannata a fluttuare per sempre, come un messaggio senza destinazione, in un oceano senza limite di frames algali e batterici, la cui origine è assente o ininfluente o inimportante (il loro scopo non è riferire o indicare ma solo rendersi co-possibili, impedire ogni emergenza, bloccare per sempre, soffocare l’epifania o l’emorragia). Eustache intravede questa fine, la fissa per sempre in questo stereoscopico dramma szondiano poi finge beffardamente nel finale una riconciliazione con il reale, finge un finale strappato che si porti via questa rassegna di fantasmi, giunti troppo tardi al crocevia della mezzanotte. La pista di catrame si è già interrotta, non c’è un finale che possa tamponare questa fine senza fine.
Rimangono non più i discorsi pseudo-ideologici di una povera donna violata ma la sua bellezza fanée di spettro rock in abito traforato mentre giace in alcove senza domani, rimane il seno insolente di Lafont, rimane il grigio radioattivo di questo sole della malinconia che non riscalda ma annienta di velo, rimangono rettangoli di cielo/bruma che vibra come un riff kossoffiano, rimangono i neri che non si rimargineranno mai, rimane il gratuito che ammonisce i suoi ospiti di non abbandonare mai queste penombre, di non progettare mai niente, di non incontrare mai nessuno, non appartenere mai all’umano. Sarà questo il senso segreto di quella battuta di Salvador Dalì secondo cui qualsiasi cosa riemerga dal catrame, come liberandosi dalla sua stretta a zampillo, beh, vale da subito almeno cinquemila dollari. È un cinema realistico e quindi apocalittico, inevitabilmente metafisico e dunque anche trascendente. Con i suoi paradisi specifici, gli unici che la disperazione e la morte rendano possibili: «Ich weiß nicht, was ich geben würde, mit Marlene Dietrich zu sein, in der Wüste, in einer Kneipe, betrinken…», ammette Jeff/ Lou Castel, indicato minacciosamente dall’estremità del promontorio, che si profila come un destino funesto su un mare verdolino come un giocattolo e senza sfondi, seduto di spalle alla baia sulla terrazza del Bellevue-Syrène di Sorrento, a una Hanna Shygulla deliziosamente, decorativamente capziosa con il suo bob ondulatorio. Ubriacarsi, piangere, nel deserto, con Marlene Dietrich. È la sola uscita possibile, oltre la morte, l’orrore di tutto.
È un cinema realistico e quindi apocalittico, inevitabilmente metafisico e dunque anche trascendente. Con i suoi paradisi specifici, gli unici che la disperazione e la morte rendano possibili: «Ich weiß nicht, was ich geben würde, mit Marlene Dietrich zu sein, in der Wüste, in einer Kneipe, betrinken…», ammette Jeff/ Lou Castel, indicato minacciosamente dall’estremità del promontorio, che si profila come un destino funesto su un mare verdolino come un giocattolo e senza sfondi, seduto di spalle alla baia sulla terrazza del Bellevue-Syrène di Sorrento, a una Hanna Shygulla deliziosamente, decorativamente capziosa con il suo bob ondulatorio. Ubriacarsi, piangere, nel deserto, con Marlene Dietrich. È la sola uscita possibile, oltre la morte, l’orrore di tutto.
Le faux c’est l’au-delà.
P.S. Quando già questo testo era terminato, è arrivata una lettera di Jean-Jacques Schuhl, insieme al suo ultimo libro, Obsessions (2014). All’inizio avevo avuto l’idea di un jeu che poteva ben essere nelle sue corde («Des surréalistes je revendique aussi les délires d’interpretation et la simulation d’hallucination…»), nella mia lettera gli chiedevo dunque una frase-déclencheur, una frase-contrainte quasiment oulipienne, una frase-esergo, una frase-serie anche enigmatica su cui modellare tutte le altre, in guisa di commentario o di divagazione multipla, una frase non necessariamente logica su Jean Eustache, di cui era stato proche per circa vent’anni, e suo compagno d’avventure all’epoca de La Maman et La Putain. Pur non faticando troppo a riconoscersi in Charles, l’amico di Alexandre, pur ammettendo che quel personaggio poteva essere il suo calco nel film, Schuhl non si era mai espresso se non in maniera molto vaga a proposito del film. Le sue preferenze («…les collages d’Aragon, leur goût pour l’attraction de pôles très différentes, le refus de l’homogène, la transfiguration, la fictionnalisation du quotidien… ») sono sempre state in evidente sintonia con l’estetica segreta del film, in qualche modo Schuhl è forse il gemello di Eustache. Se questo è vero, mi sembrava impossibile che potesse condividere l’assoluto penchant per la biografia che avevano gli altri commentatori o proches, avevo dunque pensato a lui per rilanciare l’enigma Eustache. Anche recentemente in un’intervista a Les Inrocks: «Pour moi, le fantasme et le réel s’enchâssent complètement et quand j’écris, j’essaie d’être les deux à la fois, très réaliste et fantasmatique».
Schuhl mi dice che troverò forse in Absence, uno dei testi del libro, quello che je souhaite ed è così. Non una frase, ma interi periodi che potrebbero ben costituire una sintesi dello “shandysmo” precedente o un suo riavvolgimento originario «… presque une ombre blanche… À quoi ça avance, les souvenirs, l’existence…tout ça?! Face à son cinéma si neutre, si blanc, toute anedocte semble un effet de mauvais goût, un rien devient haut en couleur, pittoresque. Ses film en un sense appellent le silence».
La frase-esergo che gli avevo chiesto, il jeu, arriva alla fine, una perfetta frase-colophon, quella in cui tutto il precedente risuona, la frase/emblema che riassume l’impresa:
«… pas fixer, juste recueillir à l’extrême surface de la pellicule tout ce qui ne veut rien dire… même pas l’absurde, ni le non-sens mais véritablement le temps mort, les mots pour les mots, la parole plutôt, juste la parole qui ne va nulle part… neutre… suspendue… C’est cela: une espèce de suspense sans histoire… la suspense de chaque instant…et les instants qui n’aboutissent jamais à une histoire… le temps… À quoi ça avance tout ça, la biographie?»)
Filmografia principale
La maman et la putain, (Jean Eustache 1973)
Warnung vor einer heiligen Nutte, (Rainer Werner Fassbinder 1971)
Welt am Draht, (Rainer Werner Fassbinder 1973)
Bibliografia principale
Schuhl J.J (2014): Obsessions, Gallimard, Paris