*Una prima versione di questo articolo è apparso su «Il Manifesto» del 15 settembre 2022.
Cosa ci lascia Jean Luc Godard? Quale eredità tratta direttamente dal bacino straripante e straziante del Novecento? Tra le tante cose, io direi la consapevolezza che non si possa fare cinema se non attingendo al cinema stesso – e assecondando la natura cinetica, cinematografica del mondo –, alla congerie di linguaggi che nel cinema s'intrecciano, si scontrano, si contrappuntano per alludere, attraverso questa materia immaginale spuria, all'esistenza, a stadi di esistenza, gradi di segnificato sia pure fugace. È proprio la neutralizzazione del significato, del significato univoco in favore della coesistenza di senso, di sensi di marcia dei segni, il fulcro di questo cinema, di questa filosofia.
Sin da principio, arrivando alle ultime cose, fino all'addio al «langage» di Godard – e il termine «cosa» non è casuale, essendo il suo cinema una ricomposizione (estetica: una cosa dell'arte, anzi una cosa del segno, una corsa di segni), interpretazione dei tanti, innumerevoli strati dell'immanenza, al limite, del caos che la scandisce e sintetizza: le cose di cui è fatta, appunto, cose parlanti – questa che resta, nonostante tutto, una delle personalità più influenti nella cultura degli ultimi sessant'anni, ha sperimentato ossessivamente – ha inteso proprio la cultura solo in quanto sperimentazione – il rapporto tra i linguaggi: cinema, letteratura, musica soprapposti uno all'altro, legati in armonia tra loro o fatti confliggere fino alla cacofonia, cercando di creare, di figurarsi una sorta di cosmogonia cinematografica.
Regista e filosofo, teorico, capace di sublimità così come di annichilimenti: cineasta nelle cui opere risuona costantemente il dialogo che si instaura al di là dei soggetti (auspice Lacan), il discorso che intercorre tra gli oggetti, le forme, la materia sibilante, farneticante, dialogo a proposito della loro esistenza, del loro apparire, fugace palpitare. Sono questi linguaggi – l'interazione, la distanza tra le diverse forme del discorso, di ogni discorso possibile – la sostanza, anzi lo strumento dell'esistente nella visione di Godard, non specificamente dell'esistenza umana, ma di una dimensione, un ente che fibrilla, germina a prescindere da noi, e in cui rutilino immagini dialettiche, frammenti sonori, parole rimbombanti frutto di una fuga dal discorso: lingua allora. È qualcosa di simile all'essere nell'accezione di Derrida, diverso dall'esserci inteso come declinazione umana dell'ente, umanizzazione del Senso, di un senso che è latente sopra le nostre teste e non può essere colto se non nel cortocircuito linguistico, «una catastrofe psicocosmica [...] contro le porte del tempo», l'addio al linguaggio che così allude alla lingua, qualcosa di minimale, di animale.
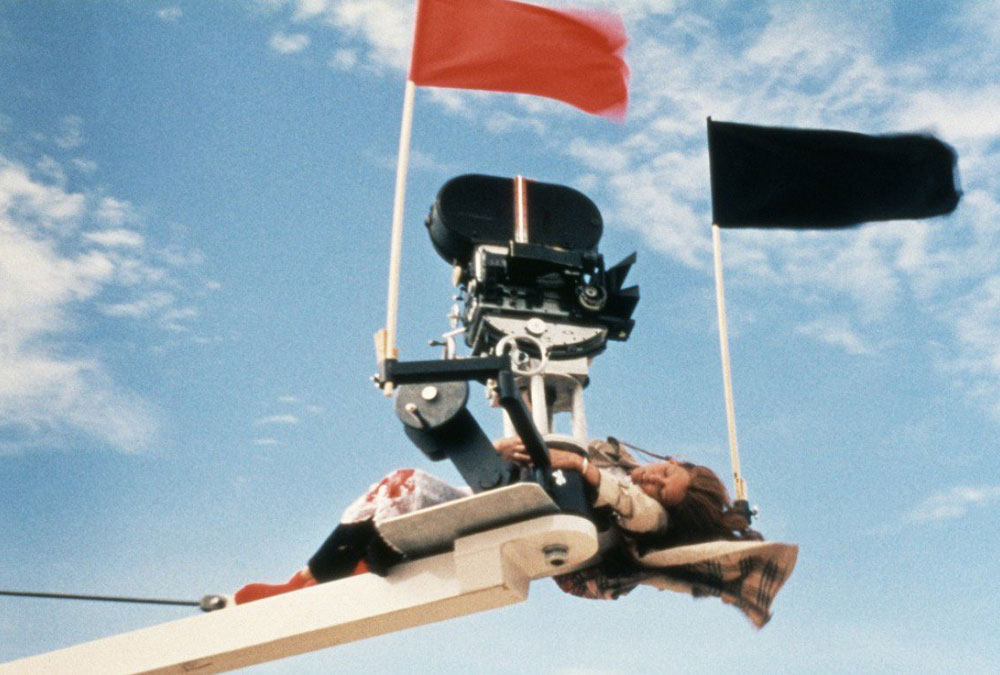
Film come One Plus One ovvero Shympaty for the Devil – in cui la disquisizione sulla musica, il discorso sui Rolling Stones, diviene spartito audio-video, fuga in chissà quale tonalità – testimoniano eloquentemente questo procedimento di «falsi raccordi», di sfagli tra le partiture, aperture tra un linguaggio e l'altro – musica non come supporto alle immagini ma come espressione a sé – che provocano la fuga del significato, l'involo del senso, o il senso come fuga dal discorso per un subitaneo, rapsodico apparire, risuonare, parlare. Fondamentale in questo cinema, com'è noto, è il montaggio, strumento privilegiato di un'oltranza che potrebbe essere anche quella del Lynch più puro; non solo il montaggio di immagini (cesure, oscure prolessi, decoupage, ecc.) ma anche del suono, della musica, e del testo, la parola, proprio la lettera in quanto segno grafico, calligramma che compare sovrimpresso all'immagine per ricontestualizzare il cinema, la natura cinetica del cosmo.
O come in Le Mepris – ma il discorso vale per ogni opera godardiana: da Fino all'ultimo respiro a Prénom Carmen (da qui in poi la musica classica sarà preponderante), fino alla cacofonia esemplare di Adieu au langage, il suono del defecare o la storpitura del «language» – capolavoro misconosciuto (il produttore Carlo Ponti ne fece una versione – italiana – jazzata, edulcorata), in cui le musiche di Georges Delerue (tra le colonne sonore più belle della storia del cinema: archi larghi, andanti, struggenti) sono espressione a sé, entità – per frammenti, per ventate musicali endogene, metafisiche, senza origine se non quella dell'intervallo, dell'eterno intermezzo – che trama (montandosi) con le immagini e con il testo moraviano per sospendere, sorprendere il discorso, in favore di un senso proteiforme, ambiguo, al di là di ogni umana morte.
