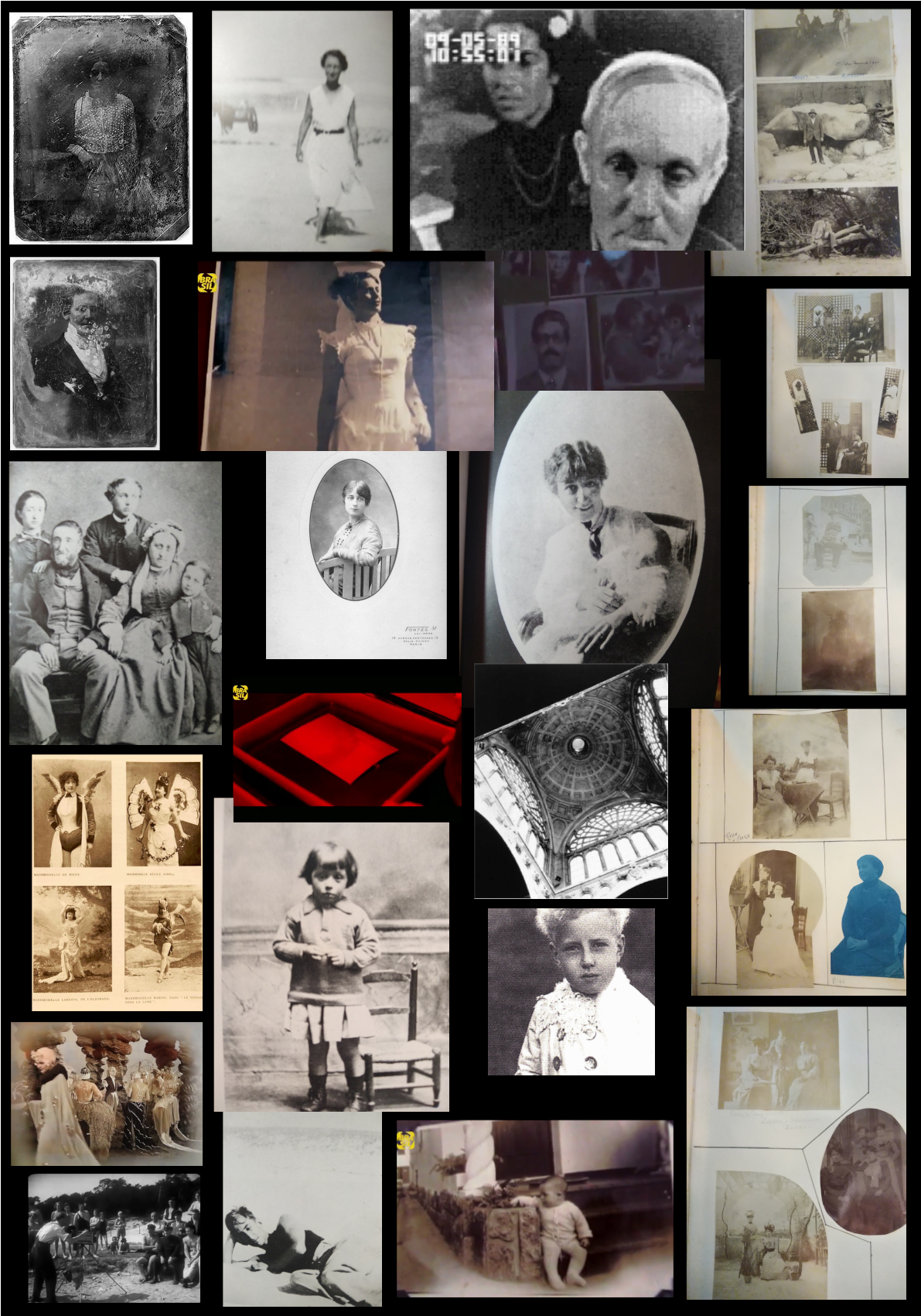La Tavola di montaggio si articola in tre sequenze longitudinali, dall’alto verso il basso. La prima a sinistra è dedicata alla borghesia: dai primi dagherrotipi al ritratto di famiglia, dagli avi mostruosi di Bataille alla classe dei padroni nel giardino delle delizie di Metropolis di Lang, fino al fotografo che, sulla spiaggia di People on Sunday, fa un ritratto involontario, composto da immagini fisse, della società “paralizzata” dell’epoca (si tratta, in un certo senso, non di un album di famiglia, ma di un album di società, fatto non di foto, ma di fotogrammi).
La sequenza centrale è quella che ripensa e rimonta alcune immagini da Barthes, Sebald e Bressane, associandole fra loro. Quella di destra monta insieme foto che risalgono all’inizio del XX secolo (lo stesso periodo di quelle nell’album di Rua Aperana 52 di Bressane, scattate a partire dal 1909) che fanno parte dell’album di famiglia di un’amica argentina. Come sempre accade davanti ad una tavola di ispirazione warburghiana è possibile (o auspicabile), a partire (o nonostante) queste brevi indicazioni, creare montaggi e percorsi propri.
«Credo che una piccola fototeca o un semplice album di fotografie di famiglia ci suggerisca uno ieri in cui l’oggi raccoglie un’energia emotiva, passionale, che ci trascina in un movimento a ritroso e in avanti nel tempo-spazio. Scossa, tremore sensibile del corpo, del corpo sensibile, una luminosità fosforica brucia la pellicola. Vive il fotogramma, nell’Atlante della memoria!» (J. Bressane, Dislimite. Scritti, p. 87).
«Una fotografia ha molti significati e molti modi di farsi ascoltare» (Ivi, p. 88).
«La fotografia installa non una coscienza dell’esserci della cosa (che ogni copia potrebbe suscitare), ma una coscienza dell’esserci stato. Si tratta dunque di una nuova categoria dello spazio tempo […] Il cinema non sarebbe fotografia animata: nel suo ambito l’esserci stato sparirebbe a favore di un esserci della cosa». (Barthes, L’ovvio e l’ottuso, p. 34).
«Decretai che amavo la fotografia in opposizione al cinema, da cui non riuscivo a separarla. Questo problema persisteva. Nei confronti della fotografia ero colto da un desiderio ontologico: volevo sapere a tutti i costi cos’era in sé, attraverso quale caratteristica essenziale si distingueva dalla comunità delle immagini» (Barthes, La camera chiara, p. 5).
«La nostra devozione alla storia è una devozione verso immagini prefabbricate, pre-registrate all’interno delle nostre menti […] non facciamo altro che osservarle mentre la verità si trova da un’altra parte, in qualche luogo nascosto e non ancora scoperto da nessuno» (Sebald, Austerlitz, p. 61)
«Quello che mi ha sempre colpito nel lavoro fotografico, è il momento in cui si vede sorgere dalla pellicola impressionata, per così dire dal nulla, le ombre della realtà, esattamente come i ricordi […] che emergono in noi nel mezzo della notte, e si oscurano rapidamente davanti a colui che vuole assoggettarli, come una copia fotografica che si lascia troppo tempo nel bagno di sviluppo» (Ivi, p. 57)
Le sei densissime citazioni poste in esergo servono a stabilire una rotta attraverso tre testi di diversa natura: un film, Rua Aperana 52 di Bressane, uno scritto diviso fra autobiografia e saggio, ossia la prima parte di Barthes di Roland Barthes e un romanzo, Austerlitz di Sebald. Il maestro del cosiddetto cinema marginale, Julio Bressane, che nei suoi film ri-monta e inserisce ossessivamente immagini eteroclite che appartengono alla storia del cinema e alla sua storia personale (il titolo del film, Rua Aperana 52, è l’indirizzo della casa di famiglia); W.G. Sebald, scrittore amante del margine inteso come territorio ibrido di scrittura (Piglia lo inserirebbe in quel genere ibrido chiamato “ficción especulativa”) che ha utilizzato, nei suoi romanzi, complessi montaggi di immagini fotografiche; e, infine, Roland Barthes, semiologo che si è interrogato continuamente sullo statuto dell’immagine fotografica e su quella che chiama la sua «immobilità amorosa o funebre», tutti archeologi, se vogliamo, della vita quotidiana, saranno ripensati attraverso quel grande libro “anatomico-magico” che è l’Atlas Mnemosyne di Aby Warburg, essendo tutti e tre grandi archivisti di storie umane, private e collettive.
Se riflettiamo un attimo sul montaggio di citazioni di cui sopra (in una forma, chissà, un poco sciatta, comunque rapida, con la promessa di approfondire tutto più avanti, grazie soprattutto ai “materiali” filmici fotografici o letterari degli autori in questione), vedremo profilarsi alcuni dei temi di questo scritto enumerati sotto forma di brevi asserzioni.
- La fotografia (o il fotogramma) è un’immagine mnemonica che si muove baluginando in avanti o a ritroso nello spazio tempo.
- La “fototeca” o l’album di fotografie è un archivio condensatore di energie inconsce che viene associato ad un Atlante (warburghiano) della memoria.
- La visione dell’immagine mnemonica provoca una scossa simile al turbamento sperimentato del narratore poesco quando ascolta, di notte, il Corvo bussare alla sua porta.
- L’ostensione dell’immagine rimanda ad un significato occulto, che si trova da un’altra parte.
- La fotografia è l’ombra rivelata della realtà. La sua emulsione è fragile. Maneggiare una fotografia, stare davanti a un fotogramma (ovvero: ad un’immagine del passato) è un atto empiricamente assai delicato. Bisogna essere storici materialisti per riuscirci. Come? attraverso un’archeologia del quotidiano.
- L’immagine del passato è un frammento di esistenza dove il remoto si aggancia con l’adesso in una costellazione – ossia un montaggio – di immagini.
Non tutte le immagini sono capaci di accendere, all’improvviso, la miccia del passato ma solo alcune. Si tratta soprattutto di immagini di vita quotidiana, documentarie, collocabili sempre al di qua dello studium barthesiano (mentre le meglio riuscite o artistiche sono quasi del tutto inutili per raggiungere questo scopo). L’immagine mnemonica funziona, nel momento in cui affiora, come una chambre verte. Il riferimento è, ovviamente, al film di “Henry Truffaut James” La camera verde, storia di un vedovo che edifica una stanza ricolma di ritratti fotografici incorniciati in omaggio alla moglie morta. Questo mausoleo dell’immagine fissa è, nello stesso tempo, un Atlas della memoria, una Mnemosyne non troppo dissimile da quella n.46 dell’Atlas di Warburg, dedicata alla Ninfa certo, ma anche saturo di morte (di Giovanna degli Albizzi riprodotta, come la donna amata nel film di Truffaut, più volte in pose differenti, ma anche della morte inconsciamente generata dalla presenza demonica di colei che diventerà, grazie ai rovesciamenti polari dell’antico, ninfa-tagliatrice di teste (vengono in mente altre due stanze peculiari: quella della ragazza de Come in uno specchio di Bergman, spoglia del tutto, invece, di immagini, ma satura di presenze, spazio in rovina teso fra una finestra e una fessura, fra l’immagine del mondo mantenuto albertianamente a distanza e geroglifico, concetto spaziale dal quale filtra o cola la voce dell’altrove; e la casa di Alejandra in Entre Heroes y Tumbas di Ernesto Sabato, grande villa in disfacimento composta da una fuga di ambienti abitati o abbandonati con, in uno dei più reconditi di essi, rinchiuso dentro una cappelliera, il trofeo di una testa tagliata e imbalsamata dal tempo).
Qualsiasi stanza isolata dal resto della casa, rimasta intatta durante decadi (o, addirittura, secoli) può diventare una chambre verte, necessariamente ricoperta da quel rado strato di poussière che, come suggerisce Bataille nel dizionario di Documents, è coltivo di fantasmi; camera verde è la cella dove si agita, sottovuoto, uno sguardo melanconico che si ostina a ritornare ossessivamente sulle stesse immagini, voltando le spalle alla piccola finestra che dà sul fuori; nello stesso tempo, «in quanto la sua tortuosa intenzione apre uno spazio all’epifania dell’inafferrabile» (Agamben, 2011 p.13), esso testimonierebbe dell’oscura saggezza dell’uomo contemplativo e del poeta. È con una “camera verde” che inizia (sull’importanza delle foto che “aprono” i libri di Barthes torneremo più avanti) La camera chiara. La prima foto è infatti Polaroid di Daniel Boudinet e mostra la testa di un letto con un cuscino davanti ad una tenda di tessuto sottile che lascia, in un certo senso, traspirare una luce verde in uno spazio ridotto al minimo; ma la chambre verte barthesiana per eccellenza è la stanza della madre morta dove Roland ha deciso di abitare. Nel diario di lutto Dove lei non è racconta (in quei giorni tremendi immediatamente successivi alla perdita) di aver appoggiato sulla (di nuovo) tastiera del letto un’icona, e posto dei fiori sul tavolo. La chambre verte è diventata «camera lucida, secondo l’accezione latina del termine lucidus che vuol dire, anche, pieno di purezza spirituale» (Didi-Huberman, 2019, p.183).
In Bressane la chambre verte è la parete di ritratti in bianco e nero di Cinema Inocente, lo studio di San Girolamo o, come vedremo, l’album di fotografie di Rua Aperana 52.
All’inizio di Austerlitz di Sebald, la camera verde è il nocturama: questa peculiare serra magica, caratterizzata da oscurità artificiale, che tipo di esistenze raccoglie? Se la stanza verde presenta istantanee (ma anche sequenze mnemoniche) raggelate del passato, quel serraglio che immette il selvatico nel mezzo della vita cittadina mostra «vite crepuscolari illuminate da una luna pallida» (Sebald, 2001, p. 6); se le immagini della camera verde sono illuminate dalla luce delle candele (o dalla luce fioca della lampada – Bachelard ha scritto cose magnifiche su questa differenza di illuminazione –) e sono capaci, auraticamente, di restituire lo sguardo, i corpi del nocturama appaiono e scompaiono restituendoci uno sguardo penetrante e fisso, per Sebald quasi filosofico. Non a caso, al nocturama segue, nel libro, la sala d’attesa della stazione di Anveres chiamata Salle des pas perdus, e i due luoghi si confondono e sovrappongono nella mente dello scrittore come in una sovraimpressione cinematografica: sala che «si riempì di un crepuscolo di oltretomba, nel quale alcuni viaggiatori si sedevano assai distanti, immobili e silenziosi» (Ivi, p. 8) e che segna l’incontro con Austerlitz. La camera verde di Sebald si moltiplica quando Austerlitz, seduto in questo luogo purgatoriale, di transito, fotografa alcuni specchi completamente oscurati: ci sarebbe da chiedersi se questa oscurità cava dell’immagine riflessa la percepisca già prima dello scatto o solo dopo il processo di rivelazione; quello che Austerlitz vuole captare, grazie alla fotogenia del dispositivo fotografico, non è, forse, l’immagine spettrale che ama aderire ai riflessi e a presentarsi rovesciata?
Warburg definirebbe apparizioni simili «immagini grisaille»: la relazione è da ritrovarsi in una relazione spettrale con le normali coordinate di spazio-tempo e nell’emersione di un patrimonio rimosso dell’estraneo-familiare (curiosa parola questa, unheimlich, alla quale Sebald fa ricorso in forma indiretta e di sfuggita quando accenna alle immagini di Londra che osserva dal finestrino del treno, “viste” – da intendersi nel senso dei Lumiere, vue – sempre uguali ma sempre aliene e sinistre). L’immagine-grisaille è, per Warburg, che la intravide in quei dettagli marginali e pagani in chiaroscuro ai lati (cioè, lo ripetiamo sui margini, in quelli che Warburg definisce le parti meno frequentate del complesso) dei sepolcri Sassetti in Santa Trinità, l’evocazione pittorica di figure di compromesso sopravviventi in un interregno di ombre, in una terra di mezzo fantasmatica. Ma oltre ad essere figure che abitano un margine, sono anche forme contagiose, capaci di affettare con il morbo dello stile elevato della mobilità antica (cito a memoria) la prosa realistica del Quattrocento fiorentino (la riflessione sulla grisaille si sposterà poi sull’Atlas Mnemosyne, precisamente nelle Tavole 44, 45, più la 49, dedicata interamente a Mantegna, e solo dopo aver “rimontato” – cioè ripensato – la cappella Sassetti nella Tavola 43). L’immagine grisaglia è l’immagine che affiora dopo che la credevamo scomparsa; rilevante è la sua natura fotogrammatica, intesa come la scrittura di una luce in movimento che viene dal passato.
In ogni caso è possibile, come direbbe Sebald, sentire come i morti ritornano o come noi siamo quasi pronti per andare via con loro (eccolo il contagio) perché «nella ripetizione compulsiva dello sguardo, ossessione nella quale si sospende il tempo reale e, come molte volte nei sogni, i morti, i vivi e i non-nati si incontrano sullo stesso piano» (Sebald, 2007, s.p.). La fotografia, questa scrittura della luce attraverso la sua fissazione, è quindi, l’esposizione di un lavorio spettrale: viene in mente Epstein quando, ne L’immagine fotografica e la morte, annota: «ecco come siete, fotografie! Solo dall’addio ricevete la vita! Solo i volti perduti si animano e si fermano, sfuggono alla comica freddezza, alla goffa povertà che c’è sempre in quei ricordi. Ogni momento possiede una qualità che anche l’otturatore più rapido non riuscirebbe a cogliere, la qualità di esistere, il presente. Solo la morte apporta questo ritocco […] Accade allora che un’immagine, fatta per gioco, conservata per dimenticare, di un morto, riveli tutta la sua anima» (J. Epstein, 2002, p. 78) e, naturalmente viene subito in mente Barthes quando pensa alla fotografia come la coscienza dell’esserci stato. Nell’istante banale di una giornata qualsiasi il morto, attraverso la capacità epifanica dell’immagine, spiega tutto di sé, viene rivelato: il fotografico è uno stereoscopio funebre, attraverso il quale la morte infonde alle immagini la vita vera.
Messo allo scoperto il ritmo peculiare del tempo perduto, facendo esperienza di uno spazio dove pare che il tempo si sia fermato, è possibile (dice Sebald utilizzando una formula strana e ricca di risonanze), che gli anni che ci eravamo lasciati dietro le spalle si trovassero tuttavia nel futuro. La capsula luttuoso-melanconica della camera verde è solo il primo stadio dell’immagine mnemonica: attraverso una torsione peculiare, essa è l’immagine sopravvivente che apre al tempo ritrovato.
La sopravvivenza è quel delicato stato che Warburg avrebbe chiamato «nachleben», vita postuma, vita-di-poi, e permette nel suo sfarfallio fantasma di riattivare la corrente del tempo che si era interrotta e tenere un appuntamento con il passato nel futuro. Bressane non parlava, poc’anzi, di un movimento delle immagini a ritroso o in avanti? La sopravvivenza è da intendersi quindi come ritorno del sepolto, che si afferra, come il sintomo, ai gesti corporei e lavora per impronta-spostamento-antitesi inaugurando una temporalità paradossale dove ciò che è morto non è mai morto davvero ma ritorna ripetendosi e spostandosi d’oggetto: il passato, nella sopravvivenza, si ripete mascherandosi, lasciando dietro di sé indizi di futuro.
Davanti ad immagini di questo tipo è possibile sperimentare quello che Ernesto Sabato chiama «presente prematuro»: il tempo non solo ritorna, ma ritornando si presenta prima del dovuto o comunque sempre controtempo, in maniera inattuale e intempestiva. Nello stesso tempo, queste immagini vanno associate, contestate, impugnate, manipolate, secondo una prassi precisa che è quella, come vedremo, del montaggio: non a caso in Bressane, che apre l’album di fotografia a un montaggio di immagini intempestive, montando insieme ai suoi film spezzoni di Vertov, Ejzenštejn, Welles, Edison, la camera verde diventa sala di montaggio e di rimontaggio della storia personale, della storia del cinema, della storia di collettiva di un paese.
I granelli di polvere di cui si nutrono i fantasmi devono, allora, farsi, come dice Bressane, «granelli dell’emulsione […] Un fremito di fotogrammi percorre, corso ricorso, uno scavo ottico che altera il pensiero, affronta il tempo, colloca il cinema dentro un teatro della Memoria, in cui tutti le storie, tutti i significanti, tutte le immagini sono, tutti designati» (Bressane, 2011, p. 193).
Nell’Atlas sebaldiano, come in quello bressaniano e barthesiano, scorrono immagini che appartengono alla sterminata tradizione dell’arte e dell’architettura europea, immagini di siti e luoghi, immagini della storia del cinema e foto di famiglia: immagini cariche di tempi eterogenei, sopravvivenze, intervalli, montate fra loro. Proviamo a catalogare alcune di queste, sapendo che il montaggio «esige un equipaggiamento mentale creativo» (Ivi, p. 194).
«Immagini della storia dell’arte e dell’architettura occidentale»: innanzitutto la definizione è un poco ambigua. Di che arte si tratta? Non certo di quella ufficiale, ma di un’arte tormentata ripercorsa da uno storiografo nauseato, che sa che «impronte di dolore […] attraversavano la storia in sottili linee innumerevoli» (Sebald, 2006, p. 13); nei suoi studi sulla storia architettonica delle stazioni dei treni Austerlitz non poteva non pensare al tormento degli addii e alla paura degli antipodi come elementi patetici in grado, come la selva rampicante sulle rovine precolombiane, di aderire all’architettura come una tumefazione fantasmatica: non a caso accenna a come gli edifici che crescono smisurati già proiettano l’ombra della propria distruzione, e sono concepiti fin dal principio con vista sulla propria esistenza ulteriore intesa come rovina (ma questo non va bene anche se lo riferiamo alla memoria?) Ne Gli anelli di Saturno, Sebald si sofferma su La lezione del dottor Tulp di Rembrandt: curioso, Warburg dedica varie tavole di Mnemosyne proprio al grande pittore olandese e una è dedicata all’aruspicina e all’anatomia scientifica con una “sequenza” di lezioni anatomiche (e immagini rembrandtiane costellano, lo ricordiamo en passant, Sao Jeronimo di Bressane).
Barthes di Roland Barthes termina con la foto di una tavola anatomica che mostra il disegno di un corpo la cui pelle è stata appena sollevata mostrando il tracciato di vene e arterie al suo interno (e inizia come vedremo, con la foto sfocata della madre): se la prima era un’immagine sfocata che appartiene alla memoria personale, l’ultima è un’immagine scorticata che non appartiene a nessuno, è la profondità cava di chiunque (chissà perché viene in mente quell’altro atlas di immagini che è Le Lacrime di Eros di Bataille: nella sua inaudita violenza, non iniziava forse anch’esso con un corpo di donna – le veneri paleolitiche – per terminare con un corpo aperto – quello del suppliziato cinese? – ). Nella tavola anatomica il corpo è ridotto ad un ammasso di radici che si diramano, una specie di tracciato filamentoso, resto di cui Barthes preferisce mettere in luce l’aspetto risibile: «Né la pelle, né i muscoli, né le ossa, né i nervi, ma il resto: un “es” balordo, fibroso, spelacchiato, sfilacciato, la palandrana di un clown» (Barthes, 2007, p. 204).
Interessante, in Sebald, è la capacità, davanti a quella immortale immagine di lezione anatomica, di avvicinarsi al dettaglio (la dissezione della mano, sproporzionata in maniera grottesca e invertita: pensiamo al dettaglio delle mani nella foto della madre vestita di bianco in Rua Aperana di Bressane) in una collocazione educativa che, spiega, rompe la struttura della composizione secondo l’ombra di una costruzione fallita. In Austerlitz il pittore olandese ritorna in occasione di una mostra visitata dal protagonista il quale, invece di osservare le opere di grande formato ripetute innumerevoli volte nei libri d’arte, e obbedendo a un segreto impulso baudelairiano, si concentra su un piccolo quadro 20x30 con una irriconoscibile Fuga in Egitto il cui punto focale è un piccolo centro infuocato. Ma pagine di Sebald sono dedicate anche a Turner (Funerali a Losanna) o alle opere del pittore Tripp che regala all’autore un’incisione che ritrae il presidente Schreber con un ragno sul cranio, quadro che suggerisce (inaudito potere dell’immagine fissa!) una precisa forma di procedere che è un’idea di montaggio: «nell’utilizzo di una prospettiva esattamente storica, nel paziente lavorio e nella connessione, alla maniera di nature morte, di cose in apparenza assai distanti» (Sebald, 2007, p. 207).
È una prima definizione, se vogliamo, di quello che si potrebbe chiamare montaggio della memoria: all’interno di una prospettiva storica (ossia di storiografo prima che di narratore), si tratta di mettere in connessione, alla maniera di nature morte (ossia di immagini fisse costituite da frammenti irriducibili e singolari di realtà), cose in apparenza distanti (cioè eterogenee, dissimili, disparate) secondo una vocazione che Bressane chiamerà «sperimentale» capace di mostrare coordinate di pensiero nuove.
È ne L’ovvio e l’ottuso che Barthes inserisce immagini che appartengono al patrimonio dell’arte occidentale, ma le scelte che fa sono assolutamente “minoritarie”: i quadri di Arcimboldo, “retore e mago”, capace della rotazione di un’immagine considerata come reversibile e oscillante tra vita e morte e le opere di Réquichot, agglomerato ripugnante ispessito in volumi, sono entrambe immagini corporali tese fra attrazione e disgusto: Barthes sembra scegliere brani di un’arte singolare, vera e propria ghiottoneria fatta di avanzi per un occhio cannibale dove i pezzi della natura morta che modulano una golosa immagine antropomorfa e gli oggetti deformati fino al parossismo dell’informe (brulichio di vermi, nido di vespe, groviglio di serpenti) entrano in collisione. In entrambi i casi è come se due diversi stati dell’alimento (come cosa e come rifiuto) entrassero in azione per creare un volto o lasciare una traccia. Traccia che diventa firma nell’arte fluttuante, in deriva, di Cy Twombly a cui il semiologo dedica un altro scritto.
Bressane più che inserire direttamente immagini di quadri che sabotano lo scorrimento della pellicola (certo fa anche questo: pensiamo agli studi di mani, alla Eva di Dürer e al cubismo sintetico in Miramar) o tentare il tableau vivant esatto (Venere Rockeby di Velazquez in Sermões) ma soprattutto assimila la grande tradizione pittorica e la rifà tropicalizzandola: Lorenzo Lotto nel sertao brasiliano di São Jerônimo, Matisse in uno studio dove si gira un film porno chanchada in Cinema inocente, fino alle luci caravaggesche in Sedução da carne.
Le “Foto di famiglia” sono i prodotti di una archeologia della vita quotidiana che conduce alla vertigine del riconoscimento: in Sebald la più celebre è quella di Austerlitz bambino mascherato da paggio della regina delle rose e perdutosi in quello che sembra un deserto bianco come la neve (piccolo Kenneth Anger pronto per il suo Sogno di una notte di mezza estate): «questo sei tu, Jacquot, nel febbraio del 1939, mezzo anno circa prima di aver abbandonato Praga» (Sebald, 2006, p.301). Si tratta di una foto studiata molte volte e dove vengono “estratti”, grazie ad una lente di ingrandimento, una serie di particolari (curioso, Bressane farà lo stesso utilizzando l’artificio cinematografico dello zoom che è un occhio che vede meccanicamente) come: il campo nudo e liscio dove si incontra la figura, senza possibilità di riconoscere il luogo; la zona oscura e cancellata dietro l’orizzonte; i capelli ricci spettralmente chiari; i sei grandi bottoni di madreperla; il cappello stravagante.
Una seconda immagine “ritrovata”, nel romanzo di Sebald, è quella della madre del protagonista, morta in un campo di sterminio. Austerlitz crede di scorgerla in un film sul ghetto di Terezin, che osserva dopo aver ottenuto una copia a camera lenta: l’immagine della madre è, allora, un fotogramma, mentre il ralenti si impossessa dello scorrimento con il suo torpore fantasmagorico rendendo le figure, che sembrano lavorare in sogno, eterne vigilambule fluttuanti (grandi archeologi di un movimento di questo tipo che stira la storia contropelo, sono due autori che hanno molto in comune con Sebald: Gianikian e Ricci-Lucchi), vittime di una febbre lenta e di un’incubazione morbosa: «un quarto d’ora dura un’ora, e si vedevano cose e persone che fino ad allora erano rimaste occulte» (Ivi, p. 239); a tutto questo vanno aggiunti i passaggi rovinati della pellicola (macchie che ricordano le foto aeree) e la colonna sonora modificata dalla modifica dello scorrimento (la polka, strascicata, diventa una grottesca marcia funebre, il commento verbale un ruggito minaccioso). All’improvviso, nel bel mezzo di questa risacca al ralenti di immagini anonime, Austerlitz crede di vederla, la madre, dietro un uomo anziano, con un incongruo fiore nei capelli, parzialmente nascosta dalle cifre dei minuti e dei secondi che si trovano sul margine alto del frame.
Rovesciando una frase di Epstein, possiamo dire che il cinematografo, attraverso la sua fotografia della profondità, da un lato vede l’angelo nell’uomo e la crisalide nella farfalla (ossia mostra all’uomo l’aspetto che avrebbe da morto o da embrione) ma, dall’altro, gli permette anche di sopravvivere alla morte attraverso una forma trasfigurata di esistenza. Ma c’è anche una seconda immagine della madre in Austerlitz: si tratta della foto, non firmata, di un’attrice, che il figlio recupera nell’archivio del teatro di Praga: entrambe le immagini sono due cortocircuiti dove la corrente del tempo fa scintille. Il ritratto fotografico serba presso di sé un’immensa carica energetica che per Sabato permette di afferrarsi al resto (inteso come rifiuto ma anche come rovina) di qualcuno a cui abbiamo voluto bene: «resti del corpo e dell’anima che sono stati abbandonati, in questa specie di lacerata e incerta immortalità dei ritratti», esistenza incerta però resistente, «la memoria, la misteriosa memoria di noi stessi, di ciò che siamo e di ciò che siamo stati» (Sabato, 2011 s.p.).
Le foto della madre e di se stesso bambino, sono frame mnestici ai quali Roland Barthes ritorna ossessivamente. Barthes di Roland Barthes inizia con una foto mossa della madre, giovane, vestita di bianco, dentro un paesaggio che lo sgranato trasforma in una specie di deserto di dune grigiastre che digradano fino a confondersi con il cielo color argento e dove affiora, come in un quadro di Dalí, incongruo come il miraggio di un’epoca remota, un carro trainato da un cavallo. Questa foto posta ad esergo vuole, crediamo, indicare un’intenzione precisa (ancorché inconscia): volgere la messa in posa della fotografia in sedimento accidentale, la fissità nella registrazione di un movimento potenziale e latente, la fotografia in fotogramma.
Si sa bene che Barthes, del cinema, non apprezzava proprio l’essere un continuum di immagini: «la pellicola (ben definito: è una pelle senza buchi) segue, come un nastro chiacchierone: impossibilità del frammento, dell’haiku» (Barthes, 1980, p. 65); nello stesso tempo, dice, ci si incolla all’immagine cinematografica come il toro con la muleta (è una metafora che sarebbe piaciuta a Leiris e a Bataille): i due peccati capitali del cinema sono quindi, per il semiologo, un continuum senza sbocchi per il pensiero (senza quell’intervallo-denkraum che per Warburg era, appunto, «lo spazio per il pensiero») e l’aderenza ammaliante e duale ad un contenuto immaginario, mentre della fotografia, apprezzava esattamente questa qualità opposta di immagine che, come scrive Didi-Huberman, «non fugge nel continuum temporale, subìto da Barthes con angoscia» (Didi-Huberman, 2020, p. 109). Perché allora il semiologo mostra, in questa foto che ha tutte le caratteristiche di immagine inaugurale, proprio la dimensione del passaggio, del movimento intensivo però congelato tipico del fotogramma cinematografico? Perché scegliere una foto che possiede tutte le qualità di un fotogramma? (un altro autore che trasforma le foto in fotogramma è, appunto, Bressane.
Come vedremo, il cineasta lo fa due volte: in primo luogo, appunto, filmandole e in secondo luogo rendendo mosse anche le immagini fisse attraverso l’uso del zoom e della camera a mano che si avvicina, scruta, indaga, come un detective indiscreto del tempo perduto). Ritornando alla foto mossa di Barthes, crediamo ci siano due spiegazioni possibili: la prima è in realtà quella più banale, la visione di un fotogramma, che per il semiologo offre «il dentro del frammento», ed elimina «la costrizione del tempo filmico» (Barthes, 2001, p. 61) non comporta niente di troppo diverso da quella di una fotografia (sono entrambi arresti in un flusso: di un film; di una vita). Ma c’è anche una seconda spiegazione: la fotografia, quando assume un aspetto fotogrammatico (ossia mosso: ci sono anche fotogrammi “fotografici”, non mossi, dove è possibile allora veder emergere, un senso ottuso), mostra dell’immagine, invece di una costellazione di punti fissi sui quali indugiare e dove può risaltare o risuonare, improvviso, lo scuotimento essenziale del punctum, una superficie liscia propizia al movimento erratico dello sguardo; se nel primo caso ad emergere è un dettaglio marginale che provoca uno scuotimento dei sensi, in questo secondo caso si tratta di un’oscillazione dello sguardo su una estensione levigata. Il punctum in un certo senso è sempre una specie di striato, di piegatura, di screziatura, mentre nel suo statuto fotogrammatico la fotografia diventa un’unica superficie oscillante dove è difficile trovare l’aggancio-punzone del punctum, e lo sguardo (e il pensiero) si trovano implicati in un movimento torbido di deriva sfocata.
La foto mossa è (almeno in questo tentativo barthesiano di autobiografia), una specie di gorgo-maelstrom dove l’occhio cede (cade) e gode di veder destituito fin dall’inizio, per un attimo, l’esercizio manipolatorio della visione attenta e si trova a poter articolare il possibile con occhi liberi (curioso: né Barthes di Roland Barthes né La camera chiara contengono altre “foto sfocate” o fotogrammatiche. L’unica, ma dove la sfocatura è dovuta all’incertezza tecnica delle immagini primordiali, è La tavola apparecchiata di Niepce, che però ci introduce in una sfocatura di tipo opposto e l’immagine diventa un banchetto di fantasmi, un emblema tecnicamente riprodotto del lavorio del tarlo del tempo che trasforma un cliché in litografia o quadro di Morandi (o a un frame dell’inizio del Don Giovanni di Carmelo Bene) a un passo della polverizzazione.
La Mamma è anche “responsabile”, negli scritti di Barthes, oltre che dell’immagine mossa, dell’immagine assente: nella seconda parte de La camera chiara l’autore accenna ad una foto particolare, quella del Giardino d’Inverno, definendola una immagine-Arianna che gli permette di analizzare la fotografia non più dal punto di vista del piacere (in esergo di Barthes di Roland Barthes non diceva forse che le immagini sono parte del piacere che l’autore offre a se stesso una volta terminato il libro?) ma da quello che si «potrebbe chiamare romanticamente l’amore e la morte» (Barthes, 2003, p.75). Alla fine, questa immagine non può mostrarla, «essa non esiste che per me. Per voi non sarebbe altro che una foto indifferente, una delle mille foto del qualunque […] tutt’al più potrebbe interessare il vostro studium: epoca, vestiti, fotogenia: ma per voi, in essa, non ci sarebbe nessuna ferita» (Ibidem). La madre è quella figura che provoca quindi, prima (nel libro dedicato al piacere della foto) un “turbamento” d’immagine” (il mosso), poi una “transvalutazione” che permette di avvicinarsi ad una polarità opposta legata alla coppia fatale amore-morte.
Diverso è il caso del Bambino, al quale va associata l’immagine dell’infanzia della Madre (di nuovo sarà l’imago materna introdurre uno scarto, un vacillamento essenziale): una foto di Roland da piccolo (non ha nemmeno due anni e lo vediamo in una spiaggia, davanti ad un paesaggio roccioso con un curioso sombrero e un secchiello) permette di alludere a Proust («contemporanei? Io cominciavo a camminare, Proust era ancora vivo e terminava la Recherche», Barthes, 2007, p. 31) mentre una seconda (Roland vestito come una bambina davanti a una parete di linda casuccia borghese, i capelli a caschetto, guarda timido davanti a sé) permette una riflessione sull’infanzia da intendersi non come luogo dell’irreversibile ma dell’irriducibile: «tutto quello che è ancora in me, a tratti; nel bambino leggo in trasparenza la parte oscura di me stesso» (Ibidem).
La foto della Madre bambina permette, addirittura, di percorrere a ritroso il tempo (aggiungendo, oltre al privilegio cinematografico del mosso quello del movimento all’indietro, amato da Epstein): viaggiando a ritroso lungo un quarto di secolo sono arrivato alla Madre bambina, dice Barthes; ma non fa lo stesso Sebald con Austerlitz? Complessa operazione archeologica questa! In entrambi gli autori la foto dell’infanzia è anche l’ultima (del libro); e se per Barthes significa perdere due volte la madre, per entrambi si tratta di ritrovare il fotografato “come in se stesso”. E foto della madre e dell’autore bambino ritornano, scintillanti del prestigio del passato, come vedremo, anche nell’album di foto di Rua Aperana 52…
C’è un momento in cui Austerlitz diventa un album di fotografie: un personaggio di nome Elias mostra infatti al narratore alcune immagini del villaggio di Llanwddyn adesso sepolto sott’acqua: si tratta di una stradina e soprattutto di persone (il pastore che attraversa il villaggio con le sue pecore, la bambina seduta nel giardino con il cagnolino in grembo): a furia di osservarle, finiscono per risultare così familiari come se anch’egli, l’essere vivente, fosse sceso ad abitare con loro nel fondo del lago (cito a memoria). Si tratta, di nuovo, di vere e proprie immagini-grisaille, immagini dell’esistenza sopravvivente e rovesciata, intraviste, per così dire, nel fondo del lago della memoria collettiva. Immagini come queste sono il deposito che, come negli scritti visionari della teoria del cinema dei primordi, diventano fantasmi vaganti per la città, riconoscibili perché sfocate leggermente sui margini.
“Immagini di luoghi, edifici o città”: in Austerlitz l’immagine della cupola della stazione di Amberes possiede un valore quasi inaugurale, mentre l’antico Monte di Pietà di Bruxelles è un inferno del potere piranesiano dove corridoi e scale non conducono da nessuna parte e il vuoto circondato da mura è il un segreto custodito dal potere. Ricordiamo inoltre che Austerlitz è impegnato in un’opera basata sulle “somiglianze di famiglia” che esistono fra edifici eterocliti dell’epoca capitalista (tribunali, carceri, stazioni di treno, borse dei valori, manicomi), caratterizzati da pulsione dell’ordine e tendenza al monumentale, ossia una storia warburghiana (e foucaltiana) dell’architettura del potere! Anche il piano dell’opera è assolutamente warburghiano, dato che si basa su interminabili lavori preparatori ed è quindi destinata al non finito, con tutto il suo fasto sovrabbondante e programmaticamente minoritario di versioni parziali.
Diverse immagine del libro autobiografico di Roland Barthes sono dedicate a Bayonne, tesa fra l’aperto (è una cittadina fluviale) e il chiuso (la sua dimensione romanzesca, balzachiana e proustiana), immagine primordiale dell’infanzia dove il narratore osserva «la provincia come spettacolo, la Storia come odore, la borghesia come discorso» (Barthes, 2007, p. 13). C’è anche un’immagine singolare, simile ad una litografia, che mostra sullo sfondo il profilo della città (delicatissimo, sembra disegnato con la punta di una matita) e in primo piano il vialetto di accesso ad un parco delimitato da un grande cancello lasciato aperto. Il vialetto è completamente vuoto ma la didascalia permette di immaginarlo come un ridotto di fantasmi dato che è lì che si incontravano le signore della borghesia bayonense con in mano il pacchettino del “Bon Goȗt”. Un’altra immagine emblematica è quella che mostra la facciata della casa di famiglia dotata di tre giardini che sono anche tre spazi con funzioni proprie: il primo è quello della mondanità, della passeggiata, il secondo è quello dei fiori e il terzo è il piccolo orticello (Barthes annota alla fine, come per caso, che la casa non esiste più, distrutta da un’immobiliare: l’immagine fotografica ritrae sempre un mondo perduto). Anche Rua Aperana, come vedremo, mostra due spazi emblematici: la foto in bianco e nero della casa di famiglia di Bressane e la strada serpentina a picco sul mare che ritorna in numerosi dei suoi film.
Le “immagini della storia del cinema” sono, in questi atlas della memoria, innumerevoli. In Austerlitz immediata è la sovraimpressione fra il protagonista e il Sigfrido de I Nibelunghi di Lang ma questa passione per l’immagine cinematografica come motore di fantasmi è onnipresente in tutto Sebald, perché sottilmente capace di suscitare il vago orrore davanti ad un mondo che, nella duplicazione potenzialmente infinita dell’immagine, si accorge che essa dura più del soggetto, perché continua ad esistere quando esso è scomparso.
In Storia naturale della distruzione il riferimento è al Mabuse (sempre di Lang), isterica messa in scena dell’essere collettivo tedesco attraverso un genio sovversivo del camuffamento e della trasformazione: andrebbero lette, queste note, vicino a quelle di Kracauer o al capitolo di Lotte Eisner dedicato al “borghese demoniaco” in Lo schermo diabolico (curioso, il “film tedesco su un giocatore” è responsabile della crisi di nervi di Cosmo in Gli emigranti: il giovane definisce il film come un labirinto dove hanno cercato di rinchiuderlo). L’espressionismo tedesco (non a caso l’epoca cinematografica forse più sovraccarica di elementi di inconscio sociale) ritorna anche in Camposanto, durante il racconto (dal sapore benjaminiano) della visita al kaiserpanorama con il riferimento a Lo studente di Praga: nel kaiserpanorama si trattava di fissare, grazie ad un visore, il fondo di uno spazio artificiale e alla fine gli spettatori sono sempre obbligati, dice Sebald, a scuotersi leggermente, per tornare ad essere proprietari del proprio corpo dopo questo transito nel mondo nelle ombre, scuotersi come la Bella Addormentata di Bataille, principessa semiseppellita nella polvere!
Ma viene in mente anche l’incipit de La Mummia di Freund (direttore della fotografia di Murnau e Lang), quando l’essere è appena ritornato alla vita ma invece del corpo intero si vede solo una delle bende sudice di millenni strisciare sul suolo polveroso della cripta fino a superare la soglia che la ricondurrà nel mondo dei vivi, immagine friabile e terribile; e, anche, il paragrafo di Schefer dedicato a La mummia di Fischer (ne L’uomo comune del cinema, che andrebbe raccontato proprio insieme agli autori di questo scritto) che indugiano, per così dire, sotto le bende polverose del mostro per permettere un faccia a faccia con l’immondo sottostante. In un certo senso, è come vedere nella bocca di Irma del fantasma cinematografico dove, però, la porta d’accesso all’informe diventano gli occhi: «questa bambola gigantesca, fatta di stracci, di bende (tutto il suo corpo è una corazza purulenta) diventa, fin nei suoi occhi fasciati, uno sguardo della putrefazione che condanna il mondo» (Schefer, 2006, p. 23).
Per Sebald i film muti sono spettrali per via dei loro temi (personalità dissociate, sosia, revenant) ma ancor di più per lo sguardo quasi trascendentale dei protagonisti, che sembrano dirigersi a una vita alla quale hanno smesso di partecipare. In Bressane i fantasmi del cinema di ieri (Ejzenštejn, Murnau, Edison, ma anche anonimi frammenti erotici) incarnano uno sguardo e un corpo che provengono dall’altrove, divenuti frammenti pulsionali rianimati dal contatto elettrico con la “macchina tropicale e marginale” del cineasta brasiliano. In Barthes il cinema deve essere ridotto, lo si è visto, al fotogramma, capace di sospendere una temporalità continua che impedisce di fermarsi all’immagine e dove gli occhi (stavolta dello spettatore) non sono né liberi né capaci di articolare quello sguardo meticoloso caro al semiologo. Barthes da un lato vuole il fermo immagine, dall’altro, una volta che ha davanti a sé questo piccolo rettangolo di pellicola divenuto disponibile, ricerca il dettaglio.
Si tratta di due aspetti contigui ma di differente portata. Il primo è collegato alla sospensione malinconica del tempo, come in una frase di Sabato: «Arrestati o tempo! […] Paralizza la vita in questo punto. Lascia che esistano sempre le tracce punteggiate della Spedizione nell’alto Perù. Che per sempre rimanga immacolato, con la sua uniforme da parata, mentre addita con l’indice il Cile, il generale José de San Martin. Che i ragazzi non sappiano mai che in quel momento cavalcava malato una mula e non un bel cavallo bianco, che era coperto con un semplice poncho, che era curvo, esitante, malato» (Sabato, 1977, p. 21): la fotografia (o il fotogramma, con il suo vertiginoso tempo in stato d’arresto, posa del tempo) permetterebbero la piega, la statusformeln warburghiana dello scorrimento incessante. Non si tratta più, solamente, di tempo interrotto, ma anche di un’immagine di copertura posta davanti al tempo storico che, nel frattempo, non ha mai smesso di scorrere. La fotografia è la toppa posta davanti al buco del reale.
Il secondo aspetto è invece legato all’emersione repentina di piccoli segni significanti che permettono una migrazione e uno spostamento di senso, come nel caso delle famose immagini della Corazzata Potëmkin di Ejzenštejn: Barthes prima accusa il cineasta di enfasi, decorativismo e di natura non polisemica dell’immagine, poi scopre una serie di dettagli secondari, degli scarti della rappresentazione (la cuffia, la linea curva delle sopracciglia, delle palpebre e della bocca di una anziana in lacrime sul porto di Odessa) ossia quel senso ottuso, discontinuo, contro-natura, distanziato, capace di eludere e sovvertire la significazione.
Julio Bressane divide il suo film Rua Aperana 52 in tre capitoli o sezioni: “foto-gramma”, “foto-dramma” e “foto-trama” (prezioso il testo di Lorenzo Esposito su Uzak https://www.uzak.it/blog/rua-aperana-52.html) e il punto di partenza è proprio l’album di famiglia, dove la foto diventa fotogramma (in un’intervista a D. Fumarola Bressane diceva che la letteratura-pittura-poesia-danza e, quindi, anche la fotografia, al cinema cessano di essere tali per diventare, appunto, cinema) e, nello stesso tempo, quello che Debord (autore assai amato da Bressane), definirebbe, in un altro testo come il Panegirico, diario privato accompagnato da un montaggio di foto, «vita privata che mi accompagna come una clandestinità», sottolineando un elemento, politico, del privato.
Debord spiega immediatamente il senso di questa frase così suggestiva: da un lato la vita privata è separata (da lui, dall’autore del diario) come lo è un clandestino; dall’altra è da lui inseparabile in quanto, come un clandestino, condivide nascostamente con lui l’esistenza. Ma la relazione fra Debord e Bressane, ci sembra, finisca qui. La domanda di Debord è se la forma della vita privata possa essere in grado di restituire un margine di autenticità in seno alle forme di esistenza alienate della vita spettacolare e se la melanconia, intesa come atteggiamento dell’uomo che monta il proprio album di foto in una posizione non troppo dissimile da quella della protagonista della stampa di Dürer, possa essere un antidoto contro forme moderne e mercantilizzate di vita; quello che si propone Bressane possiede, se possibile, un raggio d’azione più ampio (e un senso non meno politico): montare una “storia di fantasmi per adulti” dove, attraverso la gaia scienza delle dissociazioni e la ricerca ossessiva di stati-limite, è possibile mettere in luce una mnemosyne occulta della vita. In Rua Aperana 52 l’immagine del passato appare, secondo una formula di Sebald, ora muta, con una messa a fuoco quasi fissa, ora montata (Bressane direbbe dissociata) in forma brusca, precipitata o appena visibile.
“Fotogramma” inizia con la foto della facciata della casa di famiglia del regista (una facciata che subito sembra familiare, dotata di tratti quasi antropomorfi, una anti-casa Usher dell’infanzia). Questa immagine davvero intermittente, che Bressane ora muove con la punta delle dita, ora ingrandisce con lo zoom fa pensare a quella, sempre in bianco e nero, ma stavolta non quello ingiallito dagli anni dell’album dei ricordi ma quello rigato del videotape, di Strade Perdute, dove l’immagine viene turbata sia dai piccoli insulti meccanici del videoregistratore sia, soprattutto, dall’inaudito contenuto perturbante di un’immagine filmata da “Nessuno” in senso assolutamente borgesiano (per un certo periodo, inoltre, la videocassetta e il videoregistratore non sono stati forse veri e propri strumenti per produrre un immenso archivio – liquidato poi dall’usura rapida dei supporti e dall’arrivo dell’epoca digitale – in grado di conservare e riprodurre insieme film di famiglia e della storia del cinema?) La foto della facciata si unirà poi, in modo anacronistico e godardianamente esatto, con l’immagine della stradina serpentina che si inerpica a mostrare la baia, set ricorrente dei film di Bressane (in Viola Chinese, davanti all’ennesimo movimento di camera in questo vero e proprio territorio della memoria diventato leit-motiv, dice «io sono nato qui, a Rio del Cane»).
Quindi, appare un neonato che gattona diventando in un’altra foto (potenza dell’album di famiglia, che passa senza soluzione di continuità da un’epoca all’altra) un bambino sulla bici che, poi, i genitori stringono fra le braccia: le foto dell’album di famiglia diventano immediatamente fotogramma, immagine ripresa che l’artificio dello zoom, con le sue approssimazioni tattili di strumento che possiede la memoria di un cieco, dota, warburghianamente, di vita mossa (l’intelligenza di una macchina trasforma l’immagine fissa in motion picture) implicata in un falso movimento: la fotografia, ontologicamente connessa alla realtà, diventa allora una specie di immagine onirica che ingrandisce e isola l’oggetto, infilato in un tempo peculiare, soggettivo e fluttuante, dove l’ordine è del tutto associativo (cinesogno direbbe Epstein; e Bressane non diceva anche lui che il cinema è sogno, che l’arte del futuro è l’arte del sogno?). All’immagine, secondo un’idea verticale, viene aggiunto anche il sonoro attraverso il ricorso alla radio: si ascolta una canzone dei Nomadi (un po’ come fatto da Godard con una canzone di Cocciante nella sequenza delle Histoire dedicata al cinema italiano), una voce femminile della BBC, canzoni brasiliane etc. Il fotogramma è, quindi, l’iscrizione della luce su una pellicola assorbente dove può depositarsi (rilasciando “segnali”) come immagine del passato (altrove Bressane fa riferimento alla banda bianca, trasparente, dove l’immagine si deposita, e quella nera, che crea l’illusione del movimento).
In “fotodramma” vediamo la foto di una bellissima donna bruna vestita di bianco, davanti ad una colonna, con le belle braccia scoperte: viene in mente Kafka (citato da Sebald) quando scrive a Felice a proposito di una fotografia dove ella lo osserva melanconica, dall’altro lato, si direbbe, della vita (cito a memoria) «Mia cara, le immagini sono belle, non si può prescindere dalle immagini, però sono anche un tormento» (Bressane sostituirebbe a tormento «ossessione»); Kafka che parla anche della capacità, da parte del fotografo, di ampliare l’immagine, ossia scoprire elementi occulti, segreti, perturbanti come fa Bressane. La cinepresa intanto (rigorosamente a mano: la camera a mano è l’occhio che ha appreso a dire “Io”) si muove attraverso un’immagine divenuta territorio in un montaggio, appunto, di parti (le orecchie o le mani della Madre – curioso, quella sinistra nera, sembra assai più antica di quella destra, bianca, o vittima di qualche putrefazione interna – secondo un’idea quasi morelliana dell’importanza del particolare minuto) e spazi (due giovani sdraiate su una spiaggia di sabbia bianchissima, quasi giapponese con, in secondo piano, una piccola capanna da pittura zen e alberi disposti come pagode: e in Barthes di Roland Barthes non c’è la foto della Madre sulla spiaggia fra i due figli?), fino allo sfocato, quando l’immagine perde i suoi attributi di coerenza per scomparire nel nulla (in quel suo margine di deserto dove sorge e si perde: São Jerônimo è tutto su questo). Il fotodramma è quindi l’immagine soggetta ad un’azione capace di drammatizzarla (parola curiosa, già ejzenstenjana e batalliana) in una messa in movimento energicamente patetica e pulsionale provocato dalla luce e dalla sua azione tragica: «drammatizza oggetti, volti, onde, seni, nuvole, montagne, corpi» (Bressane, 2014, p. 87).
Quindi, lo scarto: l’immagine (il rettangolo bianco) viene prima mostrata immersa nel bagno per essere rivelata e, poi, cominciano i frammenti ri-montati del cinema di Bressane (26 film, in una colossale e ultra-rapida ricompilazione di tutto il suo cinema del passato che diventa “a venire”, fino al 2009), secondo una praxis poi utilizzatissima dal cineasta brasiliano che immagina un cinema-trance capace di attraversare i limiti, in uno slittamento e dislocamento continuo fra saperi, culture, immagini. L’immagine in movimento, posseduta, si rifà continuamente, di nuovo, frame: non, però, immagine fissa o congelata ma immagine che a causa di un movimento eccessivamente intensivo, sovraccarica, si blocca fra un movimento e l’altro, fra un mondo e l’altro, sospesa. Alcune presenze demoniche fanno allora il loro ingresso nel film: oggetti (la statuetta e le maschere orientali), figure (la magnifica “ninfa” di Tabù, che si muove nuda trascinandosi dietro il suo velo semitrasparente, donna vela che balla camminando; le due giovani “egizie” sul parapetto, fra le stelle filanti di Miramar; la sirena jacksmithiana riversa nel liquido amniotico, prima del lungo travelling in bianco e nero davanti alla spiaggia ridotta a plaga bianca e solarizzata mentre si ascolta una samba), riflessi (come quello dell’albero sul selciato, che crea una specie di effetto maculato), fino a tutte le immagini marine, di un cinema che obbedisce innanzitutto all’imperativo di “Miramar”, guardare il mare (o il deserto, che per San Girolamo diventa “oceano luminoso”): è il “Fototrama”, dove l’album di famiglia sfocia nella filmografia, diventando cinema, principio generatore di senso e finzioni, attraverso un movimento di camera che si è scoperto flying, aperto al gioco del dislimite.
E viene in mente, di nuovo, Sabato, in quei passi di Entre heroes y tumbas dedicati al concetto di memoria, Sabato storiografo malinconico che riflette sul concetto di storia come farebbe la Malinconia di Dürer sui suoi oggetti dislocati, pescati nel deserto del reale: «La sua memoria era composta da frammenti di esistenza statici ed eterni. Il tempo non passa, in effetti, fra di essi, e fatti che sono accaduti in epoche assai remote fra loro si trovano uniti ad altri o riuniti per strane simpatie o antipatie o salgono casualmente alla superficie attraverso vincoli assurdi però poderosi» (E. Sabato, ivi, p. 239), ossia inconsci: Bressane è chiarissimo, alla base del suo cinema ci sono movimenti involontari e scelte affettive e in questo sarebbe stato d’accordo con quell’altro grande viaggiatore e “archeologo dello spazio”, Levi-Strauss, quando scrive che le condotte in apparenza più affettive, le operazioni meno razionali e le manifestazione dichiarate come prelogiche sono, nello stesso tempo, le più significanti, perché la realtà vera non è mai quella manifesta.
Barthes, Sebald, Bressane sembrano utilizzare quindi (lo si è accennato sopra) un’idea montaggio della memoria, che mescolando insieme memoria, oblio e desiderio, vita quotidiana e evento, permetterebbe a fatti senza relazione apparente, che provengono da periodi e regioni eterogenee della coscienza privata e collettiva, individuale e storica, ma anche a luoghi topologicamente distanti, di scivolare uno dentro l’altro. Montaggio, questo, capace da un lato di associare antipodi geografici (di sfuggita: i film di Edison con le immagini brasiliane in Bressane; gli altipiani rocciosi del Sinai con quelli della terra natia in Sebald; la foto di un gruppo di liceali nel boulevard con quella di un magnifico palmizio nel deserto in Barthes) e temporali (la foto della madre e la foto di lei bambina in Barthes; l’album di famiglia del 1909 e le sequenze tratte dai suoi film fino al 2009 in Bressane, la foto di Austerlitz bambino e quella della cupola della stazione dove, adulto si incontra per la prima volta con il narratore in Sebald), dall’altro in grado di porre in evidenza un motivo che più che solamente temporale o geografico è (assai più che meramente biografico anzi, al di là di qualsiasi possibile racconto di una vita), in contatto con qualcosa di rimosso, con un enigma e, in definitiva con la morte mista sempre a quello che saremmo tentati di definire desiderio struggente non dell’assente, ma del sopravvivente.
Morte, allora, che si scopre essere non più il luogo di una irrimediabile scomparsa attuale quanto piuttosto il momento (nell’umbratile estensione fotogrammatica-fotografica che questo tipo di montaggio predilige rispetto all’irrelato scorrimento) di un passaggio, di un andirivieni, di un transito, ossia di una, inattuale, sopravvivenza. E questo è possibile attraverso la più povera delle cose, una fotografia guastata dal tempo, un rettangolo di pellicola 35mm: l’immagine sfocata dell’essere amato che permette di ritrovarlo “come in se stesso”; quella di un bambino agghindato per una festa in maschera alla quale non sapremo se parteciperà mai; la foto di una facciata scossa davanti agli occhi come il battito lieve delle ali di una farfalla, istanti che con la chiarezza della vicinanza immediata incontriamo affrancati dal flusso del tempo, il tempo che di solito, proustianamente, non è visibile, e per diventarlo cerca delle immagini, dove depositarsi e (cito a memoria) ovunque le trovi, se ne impadronisce per proiettare su di esse la sua lanterna magica. Solo allora, il tempo è ritrovato.
Testi citati
R. Barthes, Barthes di Roland Barthes, tr. it., Einaudi, Torino 2007
-L’ovvio e l’ottuso, tr. it., Einaudi, Torino 2001
-La camera chiara, tr. it., Einaudi, Torino 2003
J. Bressane, Dislimite. Scritti, tr. it., CaratteriMobili, Bari 2014
-Mnemosyne. Les signes parmi nous, in R. Turigliatto (a cura di), Passion Godard, tr. it., il Castoro, Milano 2011
W.G. Sebald, Austerlitz, tr. esp., Anagrama, Barcellona 2002
-Los emigrados, tr. esp., Anagrama 2006
-Camposanto, tr. esp., Anagrama, Barcellona 2007
-Los anillos de Saturno, Anagrama, Barcellona 2008
A. Warburg Atlas Mnemosyne, tr. esp., Akal, Madrid 2003
G. Agamben, Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale, Einaudi, Torino 2011.
G. Didi-Huberman, Popoli in lacrime, Popoli in armi. L’occhio della storia 7, tr. it., Mimesis, Milano 2020.
E. Sabato, Entre heroes y tumbas, Seix Barral, Buenos Aires 2007
J. Epstein, L’essenza del cinema, tr. it., Marsilio, Venezia 2002
G. Bataille, Documents, tr. it., Dedalo, Bari 2009
J. L. Schefer, L’uomo comune del cinema, tr. it., Quodlibet, Macerata 2006
M. Proust, Il tempo ritrovato, tr. it., Mondadori, Milano 1993